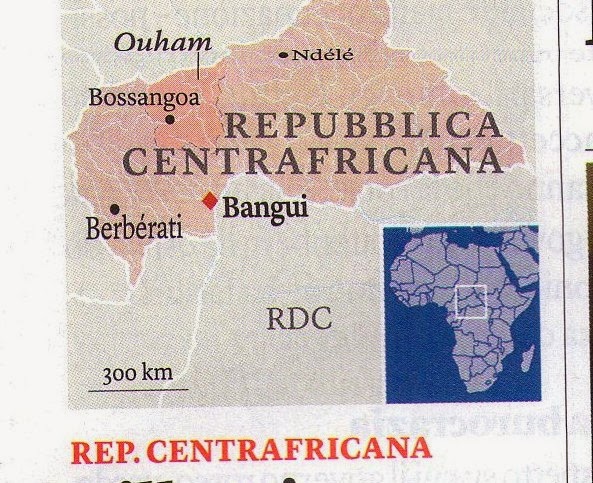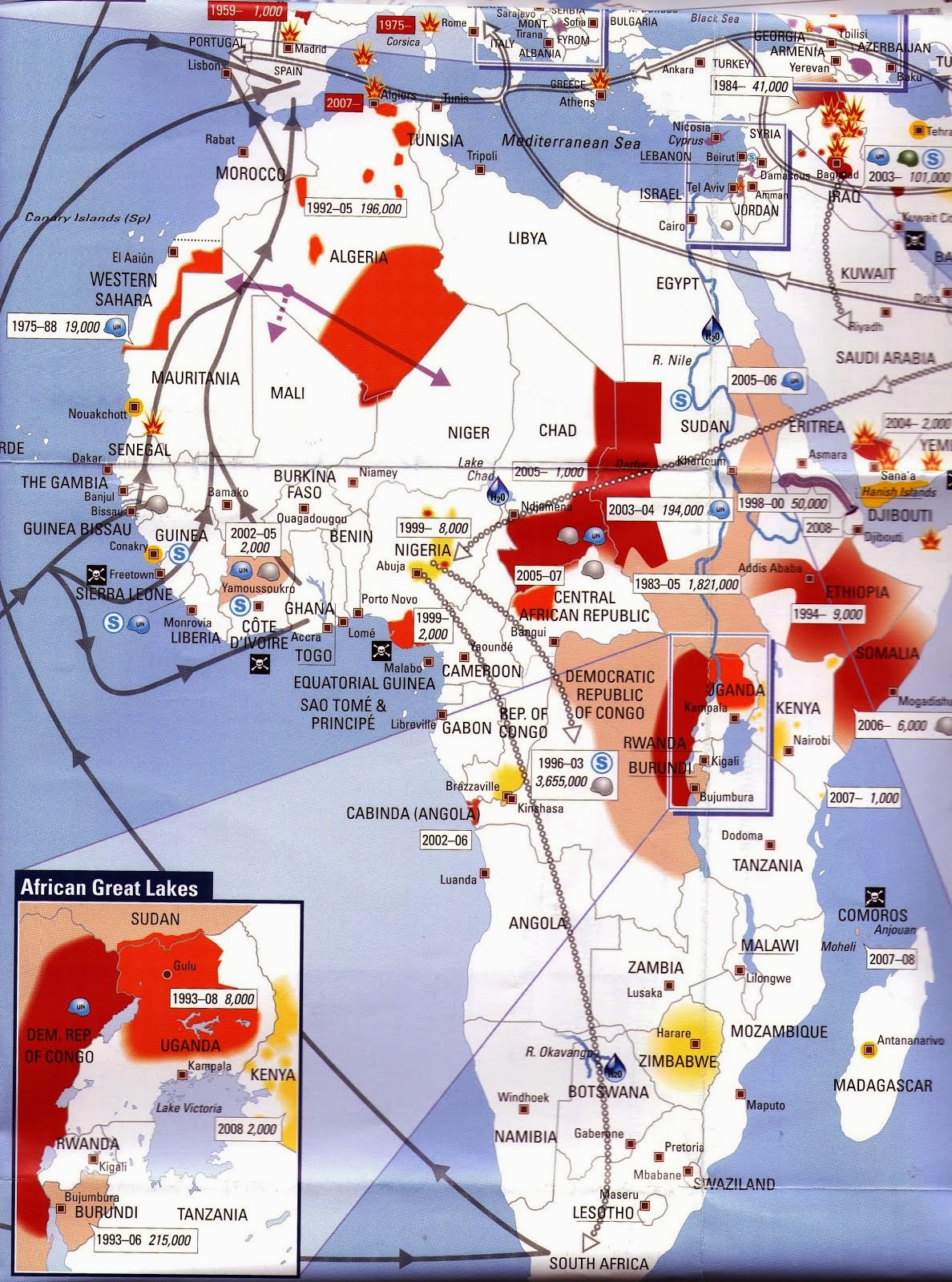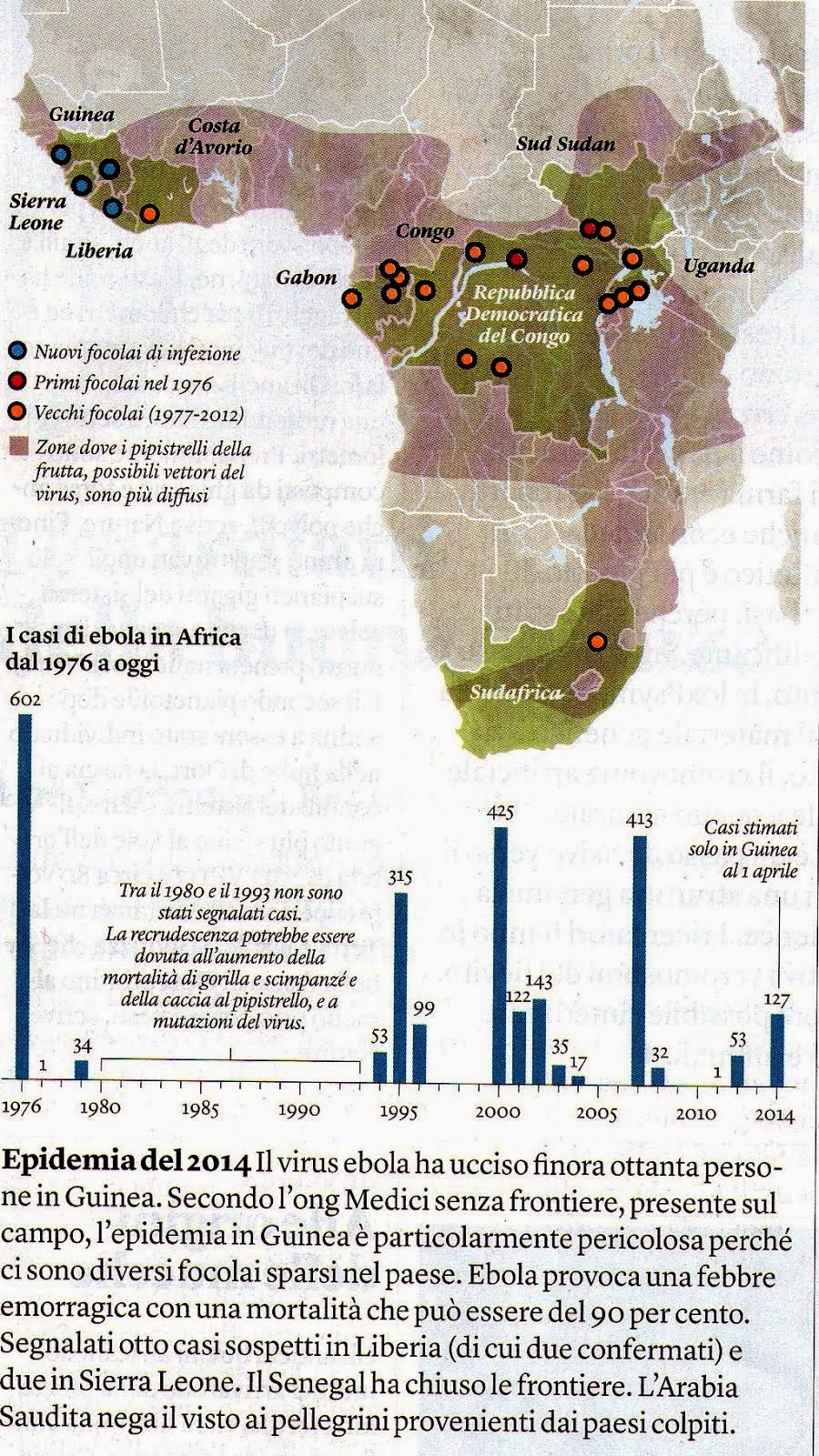venerdì 15 dicembre 2017
domenica 5 novembre 2017
martedì 19 settembre 2017
mercoledì 26 luglio 2017
giovedì 13 luglio 2017
mercoledì 12 luglio 2017
domenica 9 luglio 2017
mercoledì 28 giugno 2017
Verso una stragegia efficace
| Il G20 e l’Africa Migranti: Angela l'Africana è una risposta Giuseppe Cucchi 20/06/2017 |
|
 Angela Merkel, detta anche ‘l'Africana’? Se la risposta al quesito potesse essere positiva, si tratterebbe di un’ottima notizia che consentirebbe all'Unione europea di affrontare con efficacia il problema più grande che noi abbiamo al giorno d'oggi, un problema che tra l'altro appare destinato ad accompagnare anche i nostri figli ed i nostri nipoti investendo l'arco di almeno tre generazioni, quello dei migranti che in un flusso ininterrotto sbarcano sui nostri lidi provenendo dall’Africa nera.
Angela Merkel, detta anche ‘l'Africana’? Se la risposta al quesito potesse essere positiva, si tratterebbe di un’ottima notizia che consentirebbe all'Unione europea di affrontare con efficacia il problema più grande che noi abbiamo al giorno d'oggi, un problema che tra l'altro appare destinato ad accompagnare anche i nostri figli ed i nostri nipoti investendo l'arco di almeno tre generazioni, quello dei migranti che in un flusso ininterrotto sbarcano sui nostri lidi provenendo dall’Africa nera.Si tratta di un problema che, al di là di tutte le speranze degli altri Stati membri dell’Ue che hanno chiuso la rotta balcanica pagando il ricatto turco e hanno sospeso Schengen, sperando in tal modo di confinare i nuovi arrivati dalla nostra parte delle Alpi, rimane un problema comune a tutti i Paesi dell'Unione.
Un flusso in crescita e un problema che s’aggrava
Il flusso dei migranti è infatti un flusso, come quello dell'acqua, e dei flussi ha tutte le caratteristiche. Ci si può quindi illudere di arrestarlo, magari costruendo muri e barriere che non si capisce mai bene se siano strumento di interdizione diretto verso l'esterno o strumento di ricerca di consenso elettorale rivolto verso l'interno, ma il flusso non si arresterà mai. Magari rallenterà per un attimo, ma poi troverà sempre il modo per riprendere a filtrare.
Inoltre, se si guardano le statistiche dell'ultimo decennio, ci si accorge di come si tratti di un flusso in continua crescita, e per di più una crescita che avviene con un ritmo che lo porta ad aumentare quasi esponenzialmente. Se poi si tenta una proiezione e un confronto fra quello che avverrà in Europa e in Africa nei prossimi decenni, valutando il tutto alla luce del previsto sviluppo economico del Continente Nero, si vede come, a meno di cambiamenti radicali, il problema sia destinato ad aggravarsi e non certo a scemare con il trascorrere del tempo.
È proprio questa sua straordinaria dimensione che lo rende tanto terrorizzante da fare divenire difficile, se non impossibile, reperire il coraggio di affrontarlo con metodo e raziocinio. Come spesso succede nelle cose umane in situazioni del genere ci rifugiamo quindi nel sentimento, rifiutando di ascoltare la ragione.
I buonisti e i miopi, tra sentimento e ragione
È quanto fanno tutti coloro che si schierano per la incondizionata accoglienza dei migranti, rifiutandosi di vedere come accoglienza senza inserimento significhi consegnarli in blocco nelle mani dei caporali dell'agricoltura, dei racket della contraffazione dei marchi, dei gestori delle reti di distribuzione della droga o di quelle della prostituzione, nonché nell'isolamento dei ghetti mono-razzialio di baraccopoli di periferie degradate.
Oppure ci diamo buona coscienza affrontando il problema dell'oggi e vivendolo giorno dopo giorno per non vedere il ben più grande problema di domani. È l'ottica che domina tutte le azioni navali di soccorso in atto nel Mediterraneo, con presenze che hanno probabilmente salvato migliaia di vite umane ma che nel contempo hanno indubbiamente fatto crescere il flusso, lasciando nel contempo indisturbati o addirittura favorendo come effetto collaterale i trafficanti che su tale traffico speculano.
E ciò grazie anche all'infinita serie di auto limitazioni che ci imponiamo o per incapacità a raggiungere un accordo collettivo o per un continuo rifiuto di ricorrere alla forza giusta anche dove l'uso della forza giusta risulterebbe indispensabile.
Siamo insomma prigionieri del cosiddetto "problem solving avoidance mechanism”, cioè del riflesso che, davanti ad un problema apparentemente insolubile, o per lo meno difficilissimo da affrontare, ci spinge a crearci problemi minori più facilmente gestibili che ci tengano talmente occupati da impedirci di alzare la testa e di vedere l'interrogativo macroscopico.
Migliorare la sicurezza e combattere la povertà
Da qualche tempo in ogni caso si è cominciato a parlare di un altro modo di affrontare il flusso dei migranti, vale a dire combattendo all'origine le due piaghe che lo innescano, cioè da un lato la mancanza di sicurezza di Paesi travagliati da terrorismo, rivolte e guerre, e dall'altro l'estrema povertà accompagnata dalla totale assenza di prospettive per il futuro.
Bisognerebbe quindi evitare che gli africani fossero ridotti in quelle condizioni in cui, come disse un tempo un direttore generale della Fao, hai soltanto tre soluzioni: "o ti ribelli , o muori oppure emigri!".
Un primo tentativo di porre in opera a Bruxelles un "migration compact" si è risolto in ben poco di fatto, ma se non altro ha avuto il merito di richiamare l'attenzione di tutti gli stati membri dell'Ue sul problema , evidenziando tra l'altro come le sue dimensioni siano tali da richiedere uno sforzo collettivo della intera Unione, magari allargata a tutti gli altri Stati ad economia avanzata che riterranno opportuno partecipare.
Dal “migration compact” Ue al piano tedesco del G20
Un concetto che certo non inficia la validità delle iniziative individuali di Paesi che cercano sin da ora di fare qualcosa alla loro portata. È il caso dell'Italia con il cosiddetto ‘Piano Minniti’, che però appare molto più centrato sul settore del ripristino della sicurezza nelle aree più travagliate che su quello dello sviluppo economico.
In prospettiva ciò che appare più promettente è ora il piano di intervento che la Merkel sembrerebbe intenzionata a proporre al G20 nel corso della prossima riunione del Gruppo che verrà gestita dai tedeschi a luglio, ad Amburgo. Sono già in corso riunioni preparatorie con la partecipazione anche dei presidenti di parecchi Paesi africani, compreso quello della Guinea che è anche presidente dell'Unione africana.
Si può quindi se non altro sperare in una possibile evoluzione favorevole della situazione e perché l'iniziativa tedesca sembra destinata a coinvolgere tutte le parti interessate e perché il peso della leadership di Berlino dovrebbe risultare sufficiente a smuovere anche i riluttanti che sino ad ora si sono trincerati dietro i loro muri, metaforici o meno che essi siano.
Angela l'Africana, dunque? Auguriamocelo sinceramente!
Giuseppe Cucchi, Generale, è stato Rappresentante militare permanente presso la Nato e l’Ue e Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.
domenica 18 giugno 2017
Libia: la confusione continua
Nuove primavere arabe?
| ||||||||
 A metà maggio sono esplose in Marocco nuove proteste nella città di Al-Hoceima, centro importante del Rif, per denunciare gli alti livelli di corruzione e di disoccupazione, due dati endemici nel Paese, ma che si impennano nelle regioni lontane da Rabat. A metà maggio sono esplose in Marocco nuove proteste nella città di Al-Hoceima, centro importante del Rif, per denunciare gli alti livelli di corruzione e di disoccupazione, due dati endemici nel Paese, ma che si impennano nelle regioni lontane da Rabat.Le manifestazioni sono avvenute a sette mesi dalle sommosse seguite alla morte di Mouhcine Fikri, il pescatore che rimase schiacciato da un camion nel tentativo di recuperare la sua merce sequestrata dalle autorità. La folla si è mobilitata con forza nelle strade delle città del Nord e la polizia ha inasprito le misure di sicurezza, già particolarmente dure dopo gli eventi di novembre. Il leader delle proteste è Nasser Zefzafi, guida del movimento Hirak, che rappresenta l’opposizione nel Rif. I media governativi hanno accusato il leader e la popolazione locale di minacciare l’integrità dello Stato, sostenendo che Zefzafi è un leader separatista pagato da potenze straniere per minare la stabilità. Nel contempo, il governo ha riconosciuto le problematiche che la regione vive e si è proposto di lanciare un serio piano di sviluppo economico. La regione del Ruif Il Rifè sempre stata una regione ribelle, innanzitutto per l’alta presenza di berberi. A questo dato di carattere identitario si deve aggiungere che è una delle aree meno sviluppate del Paese: ciò ha sempre segnato gli sviluppi della società locale e il suo rapporto con il governo centrale. In questa zona del Paese negli Anni 20, al momento dell’indipendenza dalla Spagna, la popolazione aveva creato una repubblica indipendente, usando come simbolo la bandiera berbera, con a capo Abdelkrim al-Khattabi, che tutt’ora è considerato un eroe locale. La repubblica fu riconquistata dalle truppe della monarchia marocchina in pochi mesi, ma i ‘lealisti’ furono costretti a sedare nuovamente una rivolta nel 1956 quando la popolazione si ribellò per le condizioni di vita proibitive. In quel frangente fu imposta la legge marziale, la rivolta fu sedata nel sangue e l’allora monarca Hassan II arrivò a definire gli abitanti dei selvaggi, paragonandoli a delle bestie. Per molto tempo la legge marziale non venne abrogata. La Hogra e la disoccupazione La situazione nella regione è rimasta nel tempo molto dura e nel 2011 quando iniziò la primavera araba in Marocco, fu una delle zone più attive nelle manifestazioni e anche il luogo in cui si registrarono gli unici scontri. Il monarca Muhammad II, con una posizione diplomatica, è riuscito a calmare le rivolte garantendo dei diritti culturali alla popolazione berbera e aprendo un processo per garantire alla zona maggiore autonomia. La situazione politica era sembrata migliorare fino quando a novembre l’uccisione di MouhcineFikri ha fatto riesplodere le problematiche. Al centro delle proteste di novembre e di metà maggio ci sono due temi fondamentali.Il primo è indicato dalla parola araba “hogra", che indica la perdita di dignità profonda di un individuo. Questo concetto, spesso ripetuto negli slogan delle proteste, definisce la condizione di vita della popolazione locale. Lo Stato centrale è considerato il responsabile di questa situazione: infatti, la totale assenza dello Stato permette ai governatori e alla polizia locale di diventare i padroni incontrollati di quelle zone, trasformando la corruzione nella regola economica della regione. Inoltre la decisione del governo centrale di aderire a regolamentazioni internazionali sulla pesca ha privato l’area di uno dei mezzi fondamentali per il proprio sostentamento. Il secondo è la disoccupazione, in particolare giovanile. Il Marocco, come tutti i paesi del Nord Africa, è duramente colpito dalla crisi occupazionale che raggiunge picchi del 30%, ma nelle zone periferiche, come il Rif, il dato si impenna anche oltre. Le soluzione del governo Lo sviluppo economico, guidato dallo Stato, si è concentrato nelle regioni del centro, mentre il Sud sopravvive grazie al turismo. In questo quadro il Nord non riesce a trovare mezzi di sostentamento adeguati. Questi due problemi sono adesso percepiti centrali da re Muhammad II che ha risposto in modo molto diverso alle proteste di questi giorni e ha aperto una commissione che valuti un piano di sviluppo economico per il Rif. La monarchia ha confermato la capacità di capire le profonde problematiche del Paese, non utilizzando solamente lo strumento coercitivo, ma promettendo e lavorando sul fronte economico, confermando le proposte che erano state portate avanti nel 2011. Nonostante tutto questo processo, mancano in realtà veri risultati. Non sembra infatti che le misure prese nel campo dello sviluppo possano realmente riuscire a risolvere il problema a breve termine. Emanuele Bobbio è laureato all’Università di Roma la Sapienza in Scienze politiche e Relazioni internazionali, collabora con diversi giornali universitari mentre porta a termine la magistrale in International Relations presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna. |
mercoledì 31 maggio 2017
Tripoli: il Cairo all'offensiva
| ||||||||
 Il 26 maggio 2017, l’aviazione egiziana ha effettuato sei raid aerei in Libia, colpendo postazioni e campi di addestramento di presunti gruppi terroristici nell’est del Paese. Il 26 maggio 2017, l’aviazione egiziana ha effettuato sei raid aerei in Libia, colpendo postazioni e campi di addestramento di presunti gruppi terroristici nell’est del Paese.L’attacco è avvenuto poche ore dopo l’attentato di Minya, 250 chilometri a sud del Cairo, dove un gruppo di miliziani aveva aperto il fuoco contro un bus che trasportava cristiani copti diretti in pellegrinaggio presso il monastero di Anba Samuel, causando almeno 29 vittime e 24 feriti. In un discorso televisivo, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha condannato l’attacco, avvisando che l’Egitto non avrebbe esitato a colpire le basi dei terroristi, sia all’interno che all’esterno del Paese. Nelle stesse ore l’aviazione egiziana lanciava raid aerei contro Derna, dove - secondo fonti del governo del Cairo - sarebbe stato pianificato l’attacco di Minya: tra gli obiettivi, campi di addestramento e depositi di armi del Derna Mujhahidden Shura Council (Dmsc), una coalizione islamista che controlla la città dal 2015. Nelle ore successive, nuovi attacchi aerei egiziani hanno colpito invece Jufra, Waddan e Hun, mentre il 29 maggio l’aviazione egiziana è tornata nuovamente su Derna, colpendo l’entrata occidentale della città e il quartiere di Dahr al-Homir. Non è la prima volta che il Cairo lancia attacchi aerei in Libia. Basti ricordare il raid effettuato il 16 febbraio 2015, quando l’Egitto rispose alla decapitazione di 21 copti egiziani rivendicata dalla filiale libica del sedicente Stato Islamico con attacchi aerei proprio su Derna. Anche oggi come allora la furiosa reazione egiziana è stata evidentemente determinata dalla forte emozione per l’attentato subito. L’offensiva del Cairo nell’est della Libia ha tuttavia sollevato numerosi dubbi, in particolare riguardo la responsabilità dei gruppi colpiti e le reali motivazioni dietro la scelta di intervenire nel complesso teatro libico. I dubbi sull’offensiva del Cairo Il 27 maggio, infatti, il Dmsc ha negato ogni responsabilità nell’attacco di Minya. Il gruppo islamista ha inoltre definito gli attacchi aerei egiziani un diversivo per il regime di al-Sisi, una mossa utile a distogliere l’attenzione dalla crisi economica e dal deterioramento delle condizioni di sicurezza in Egitto. Il giorno stesso, l’Isis ha invece rivendicato l’attentato terroristico di Minya. A differenza di altri casi, la rivendicazione sembrerebbe verosimile, in quanto già nei mesi scorsi i miliziani jihadisti della filiale egiziana del Califfato - meglio conosciuta come Wilayat al-Sinai e precedentemente nota come Ansar Beit al-Maqdis - si erano resi protagonisti di attacchi terroristici contro i copti in Egitto. L’eventuale veridicità di tale rivendicazione basterebbe ad inficiare la tesi della pianificazione dell’attacco di Minya a Derna. Il Dmsc è noto per la sua forte avversione verso il gruppo guidato da Abu Bakr al-Baghdadi, a causa della rivalità all’interno della galassia jihadista tra al-Qaeda e il sedicente Stato Islamico: tra i gruppi che fanno parte del Dmscvi sono infatti diverse formazioni legate ad al-Qaeda. Nel giugno del 2015, la rivalità tra Dmsc e Isis si è trasformata in uno scontro aperto, terminato con l’allontanamento di quest’ultimo dalla città di Derna. Ad aumentare i dubbi sulle reali motivazioni dell’offensiva egiziana contribuisce anche il fatto che da diversi mesi Derna è sottoposta all’assedio del Libyan National Army (Lna). Le forze del generale Khalifa Haftar hanno da tempo bloccato ogni accesso alla città ed effettuano sporadici attacchi aerei contro il Dmsc. Poco prima dell’offensiva egiziana, l’Lna aveva anche concesso un alleggerimento del blocco di Derna, consentendo l’ingresso in città di una serie di beni di prima necessità. Le difficoltà dell’Lna L’Lna fedele ad Haftar è il principale beneficiario dell’irruzione egiziana sullo scenario libico. Oltre a Derna, i raid aerei egiziani hanno infatti interessato la base aerea di Jufra, negli ultimi mesi teatro di scontri tra l’Lna e la Terza Forza, una milizia di Misurata inviata nel sud della Libia nel corso del 2014 per mantenere i delicati equilibri tra Tebu, Tuareg e Awlad Suleiman. La Terza Forza è supportata nella sua azione dalle Benghazi Defence Brigades (Bdb), milizia islamista protagonista dell’offensiva nel “crescente petrolifero” lo scorso aprile. Sia la Terza Forza sia le Bdb hanno partecipato all’attacco a sorpresa alla base aerea di Brak al-Shati, non lontano da Sabha, del 18 maggio scorso: il blitz, secondo alcune fonti, avrebbe causato la morte di circa 184 combattenti della 12° Brigata dell’Lna e provocato le dimissioni del suo capo, il generale Mohamed Ben Nayel. Oltre a sollevare le denunce di diverse Ong che hanno accusato le milizie di crimini di guerra e dell’esecuzione di almeno 30 prigionieri, il massacro di Brak al-Shati ha messo nuovamente a nudo le debolezze dell’Lna, incapace di difendere una base strategica nel sud della Libia e fortemente decimato dall’attacco a sorpresa. Le reali motivazioni di al-Sisi In tale dinamico e frammentato contesto, ecco quindi che gli attacchi aerei egiziani in Libia sono stati mossi da una serie di motivazioni forse più importanti della stessa lotta al terrorismo. L’offensiva del Cairo va innanzitutto a sostenere Haftar, la principale carta in mano al regime egiziano di al-Sisi in Libia. Nonostante le dimostrazioni di forza (come la parata di 12.000 combattenti dell’Lna in occasione del terzo anniversario dell’Operazione Karama a Tocra, lo scorso 16 maggio), Haftar sembra sempre più in difficoltà. L’azione del Cairo va quindi a puntellare la sua posizione, confermando una vicinanza già dimostrata durante la recente visita a Bengasi del capo di Stato maggiore dell’esercito (e capo del Comitato nazionale egiziano sulla Libia) Mahmoud Hegazy. I raid aerei egiziani rappresentano inoltre un chiaro messaggio ai partner/competitor regionali. Messo ai margini dalla mediazione degli Emirati Arabi Uniti, che hanno di fatto rilanciato il processo di pace in Libia organizzando l’incontro tra Haftar e il primo ministro del governo di accordo nazionale Fayez al-Sarrajad Abu Dhabi il 2 maggio scorso, il governo del Cairo ha reagito immediatamente. Gli attacchi aerei ribadisconol’impossibilità di trovare una soluzione alla crisi libica senza tenere in considerazione gli interessi dell’Egitto. E l’irritazione con la quale Algeri ha accolto la notizia dei raid su Derna, elevando lo stato di allerta delle proprie forze aeree sul confine orientale - e convocando una riunione d’urgenza dei ministri degli Esteri di Algeria, Egitto e Tunisia - evidenzia altrettanto bene come sia impossibile comprendere la crisi libica senza collocarla adeguatamente nella sua dimensione regionale. Umberto Profazio è dottore di ricerca in Storia delle Relazioni Internazionali presso l’Università di Roma “Sapienza”, ACD Analyst per l’International Institute for Strategic Studiese Maghreb Analyst per la NATO Defence College Foundation. |
venerdì 19 maggio 2017
LIbia: ancora incertezze
| ||||||||
 Si sono incontrati ad Abu Dhabi lo scorso 2 maggio, dove avrebbero discusso di alcune questioni importanti per il futuro della Libia: da una parte il generale Khalifa Haftar, capo dell’Esercito nazionale libico e uomo forte di Tobruk, dall’altra Fayez al-Serraj, premier del governo di accordo nazionale riconosciuto dall’Onu. Si sono incontrati ad Abu Dhabi lo scorso 2 maggio, dove avrebbero discusso di alcune questioni importanti per il futuro della Libia: da una parte il generale Khalifa Haftar, capo dell’Esercito nazionale libico e uomo forte di Tobruk, dall’altra Fayez al-Serraj, premier del governo di accordo nazionale riconosciuto dall’Onu.Dopo una serie di mediazioni fallite, spesso a causa dell’atteggiamento poco collaborativo del generale, questa volta gli sponsor di Haftar - Emirati Arabi Uniti, Egitto e Russia su tutti - sembrano aver ricondotto il figliol prodigo a più miti consigli. L’evento è stato accolto con un certo ottimismo dalle cancellerie internazionali, tuttavia è bene non farsi troppe illusioni: “l’intesa di massima” discussa nella capitale degli Emirati presenta molte criticità sia per l’assetto istituzionale che potrebbe generare sia in termini di concreta applicabilità. Tobruk e il modello al-Sisi Partiamo dal primo punto. Premesso che i dettagli sono ancora poco chiari, la proposta politica che sarebbe scaturita dall’incontro è decisamente sbilanciata verso Tobruk, il che non dovrebbe stupirci visto che è stata mediata dai suoi alleati. In sintesi: elezioni entro marzo 2018, scioglimento delle milizie locali, formazione di un nuovo Consiglio presidenziale non più composto da nove membri ma da Serraj, Haftar e dal presidente del Parlamento di Tobruk Aghila Saleh, fedele al generale, e, forse, un comando delle Forze armate maggiormente svincolato dal controllo del governo civile, come invece imposto dagli accordi di Skhirat del 2015. Detta in altri termini,il generale della Cirenaica in un colpo solo potrebbe avere l’istituzione più importante del Paese dalla sua parte, con Serraj in minoranza, un ruolo militare di primo piano e la possibilità di presentarsi alle elezioni, magari vincendole in assenza di una valida alternativa. Le conseguenze di un tale scenario non sono difficili da prevedere: una deriva verso un modello militare sullo “stile al-Sisi”. Un’ipotesi destinata a rivitalizzare il fronte islamista e portare il Paese verso una deriva securitaria, così come accaduto in Egitto. A livello internazionale, la Russia, forte del paventato disimpegno americano in Libia, avrebbe “chiuso il cerchio”, con una rafforzata partnership tra Tripoli e il Cairo utile alla sua proiezione strategica nell’area. Milizie e lotta al terrorismo Se questo è il quadro teorico che emerge dalle frammentate informazioni trapelate sui media locali, all’atto pratico i punti del possibile accordo presentano non poche criticità in termini di fattibilità. In primo luogo, si è parlato della necessità di sciogliere i gruppi armati e di integrarli in un unico esercito sotto il controllo di Haftar. Il tema del disarmo delle milizie è la spina nel fianco della Libia fin dal 2011 quando, dopo la morte di Gheddafi, i miliziani raccolti sotto il Consiglio nazionale di transizione si sono rifiutati di consegnare le armi e di integrarsi in un esercito regolare, alimentando tendenze centrifughe, impegnate a creare entità autonome basate su rivendicazioni territoriali o di risorse. Difficile credere che possano decidere, senza colpo ferire, di cedere le armi. L’ipotesi più plausibile è quella di una recrudescenza degli scontri tra diverse fazioni del territorio. In secondo luogo, va considerato il possibile orientamento delle formazioni islamiste, soprattutto nella zona di Tripoli, controllata parzialmente e a fatica da Serraj. Giova fare un passo indietro. Haftar si è accreditato nel panorama libico post-rivolte nel 2014, lanciando l’operazione dignità contro le forze islamiste. Da allora si è auto-proclamato baluardo della lotta al terrorismo, legittimandosi in chiave anti-jihadista, senza alcun discrimine tra le forze moderate e i gruppi dichiaratamente radicali. Un atteggiamento che gli è valso un palmarès di alleati e sponsor di primo piano da al-Sisi a Putin, ma anche molti detrattori sia a livello locale che regionale. È facile prevedere che, soprattutto in Tripolitania, diversi gruppi non accetteranno un ruolo di primo piano per il nemico giurato. Tra questi, le numerose milizie di Misurata, una sorta di “terzo potere” in Libia, fin qui parzialmente fedeli al premier di Tripoli ma che mal digerirebbero un suo possibile cedimento. Alcuni gruppi misuratini hanno già abbandonato Serraj e altri ancora potrebbero farlo, rendendo così ancora più isolato il premier del governo di accordo nazionale. Difficile credere che il debole premier tripolino, davanti a un tale scenario, possa acconsentire alle richieste dei mediatori di Abu Dhabi.I problemi non mancherebbero neppure a livello regionale:Turchia e Qatar, che sostengono da sempre gli islamisti di Tripoli,non resteranno in silenzio davanti alla deriva del Paese verso gli avversari regionali. Ribilanciare la mediazione con Tripoli Il quadro sembra davvero a tinte fosche e la stabilità della Libia ancora lontana. Forse, per evitare un nuovo ginepraio, sarebbe utile riprendere in mano gli strumenti della diplomazia e ribilanciare i termini della mediazione, oggi completamente appannaggio degli sponsor di Tobruk. Un maggior coinvolgimento - e una maggiore convinzione - di alcuni attori regionali, come Algeria e Tunisia, potrebbe essere un buon inizio. Tuttavia, senza un’azione più incisiva e coesa degli Stati europei, al momento più interessati alla realpolitik che all’agire comune, poco potrà essere fatto. In un contesto così delineato, l’Italia, fin qui vicina a Tripoli, potrebbe ancora aspirare a un ruolo di mediatore per la stabilizzazione della Libia. Michela Mercuri insegna Storia contemporanea dei paesi mediterranei all’Università di Macerata ed è editorialista per alcune testate nazionali, tra cui Huffington post, sui temi della storia e della geopolitica del Medio Oriente e del Nord Africa. |
mercoledì 10 maggio 2017
Algeri: elezioni da interpretare
| ||||||||
 In un contesto di affluenza alle urne costantemente bassa e in calo rispetto al 2012, le elezioni legislative del 4 maggio in Algeria hanno riconfermato il Fronte di Liberazione nazionale (Fln) primo partito del Paese, con 164 seggi su 262. In un contesto di affluenza alle urne costantemente bassa e in calo rispetto al 2012, le elezioni legislative del 4 maggio in Algeria hanno riconfermato il Fronte di Liberazione nazionale (Fln) primo partito del Paese, con 164 seggi su 262.Il voto si è svolto in un contesto di generale apatia popolare, che dimostra un crescente disinteresse dell’opinione pubblica e un calo di fiducia complessivo nella classe politica in Algeria. L’affluenza appena del 38% evidenzia ampiamente questo dato, nonostante il governo abbia cercato in tutte le maniere di procurarsi un’ampia partecipazione popolare (le autorità hanno esortato gli Imam delle moschee a invitare i fedeli delle loro comunità a recarsi alle urne). L’affluenza è stata di poco superiore a quella delle elezioni del 2007 (35%), ma molto inferiore a quella del 2012 (43%). Allora però le elezioni si svolgevano nella scia delle cosiddette Rivolte arabe: il tasso di partecipazione popolare relativamente elevato alle elezioni legislative del 2012 si può spiegare in questo contesto. Sfiducia verso i partiti e il Parlamento Tutto ciò indica come la percezione generale algerina sia di sfiducia verso il Parlamento, che in effetti non ha molto peso nelle decisioni del governo. È il presidente, insieme alle forze di sicurezza e militari, che detta le linee guida del Paese, mentre il Parlamento, dominato da alleanze di partiti filo-governativi, si limita a dare il proprio consenso a queste politiche. Per queste ragioni, nessuno si aspettava una partecipazione popolare significativa a queste elezioni; e infatti il tasso di partecipazione è tornato a quello che era prima delle Rivolte arabe. Quanto allo spostamento di voti che si è registrato tra l’Fln (220 seggi su 462 nel 2012 contro i 164 di ieri) e il Raduno nazionale per la Democrazia (68 nel 2012, 97 nel 2017), questo dato può essere interpretato come un ulteriore segnale di distacco popolare dal partito che ha guidato l’Algeria quasi interrottamente dall’indipendenza del 1962 ad oggi. Successore di Bouteflika cercasi Sebbene l’Fnl rimanga ancora il principale partito in Algeria, queste elezioni fanno emergere la grave crisi d’identità e fiducia che sta attraversando il partito sotto la guida del presidente Bouteflika, al potere dal 1999. I problemi di salute del presidente sono ben noti e vi sono scontri di potere nel partito per farne emergere un successore. Lo spostamento di voti è anche un segnale politico che chiede un urgente ricambio generazionale nel partito e più chiarezza sulle linee guida che ne formano il programma. Il voto ha inoltre registrato un lieve aumento dei consensi per i partiti di matrice islamista, usciti sconfitti dalle elezioni del 2012, quando sull’onda delle Rivolte arabe in molti se ne aspettavano, invece, dei risultati migliori in Algeria. Il ruolo dei partiti islamici Ma la situazione politica in Algeria è ben diversa da quella dell’Egitto o della Tunisia. In Algeria vige un sistema multi-partitico dal 1989. E dunque le élite politiche del Paese hanno una ottima esperienza di giochi e strategie politiche voltr a frammentare e a cooptare possibili movimenti di protesta e/o di opposizione politica. Il principale partito di stampo islamista ad avere raccolto buoni risultati nelle elezioni del 4 maggio è il Movimento della Società per la Pace (Msp), partito affiliato alla Fratellanza Musulmana, ma che in passato ha dato sostegno al governo del Fnl anche in Parlamento. Per questo, i 33 seggi vinti dall’alleanza tra Msp e Fronte per il Cambiamento (Fc) non possono certo costituire una vera e propria opposizione politica in parlamento. Va comunque ricordato che l’alleanza vincente tra Fnl e Rnd hanno seggi a sufficienza per approvare leggi in Parlamento senza il sostegno di altri partiti. Una difficile situazione socio-economica Il calo del consenso e della fiducia popolare verso le istituzioni politiche va certamente analizzato anche alla luce di una situazione socio-economica interna al Paese molto problematica. Un algerino su tre è senza impiego e il governo ha dovuto annunciare una serie di riforme economiche e tagli ai sussidi che hanno di molto ampliato il disagio popolare. L’economia algerina rimane completamente dipendente dalle esportazioni di idrocarburi e il crollo del prezzo del greggio - combinato alle crescenti minacce di sicurezza alle frontiere algerine - hanno di molto complicato l’outlook economico del Paese. Nel 2016 l’Algeria ha registrato un deficit del 12% del Pil e il governo ha dovuto cancellare molti investimenti in grandi opere di alloggio e infrastruttura. In particolare, l’Algeria soffre di una carenza di alloggi per la popolazione, fonte di particolare proteste popolari. Anche i fondi di riserva stranieri derivati dalla vendita di idrocarburi sono diminuiti in maniera preoccupante, da 196 miliardi di dollari nel 2014 a 114 miliardi di dollari nel 2016. Senza una riorganizzazione dell’economia e significative riforme istituzionali, il Paese rischia nuove ondate di proteste popolari, ma questa volta il governo non avrà a disposizione il denaro necessario per ‘comprare’ la pace come fece nel 2011 in seguito alle rivolte popolari in Tunisia, Egitto e Libia. Andrea Dessì è Ricercatore nel Programma Mediterraneo e Medioriente, IAI; Fabiana Luca è stagista per la comunicazione dello IAI. |
mercoledì 3 maggio 2017
Egitto: la visita del Papa
| ||||||||
 Il 28 e 29 aprile, poche settimane dopo l’incontro con Trump a Washington, il presidente egiziano al-Sisi si appresta a ricevere Papa Francesco. Nel mezzo, ci sono stati due terribili attacchi terroristici, che il 9 aprile hanno colpito la cattedrale copta di San Marco ad Alessandria e la chiesa di San Giorgio di Tanta. Il 28 e 29 aprile, poche settimane dopo l’incontro con Trump a Washington, il presidente egiziano al-Sisi si appresta a ricevere Papa Francesco. Nel mezzo, ci sono stati due terribili attacchi terroristici, che il 9 aprile hanno colpito la cattedrale copta di San Marco ad Alessandria e la chiesa di San Giorgio di Tanta.I due attacchi da un lato confermano che la comunità cristiana in Egitto rimane uno dei principali bersagli della violenza jihadista e dall’altro minano le basi del patto ‘non scritto’ tra al-Sisi e i suoi alleati occidentali. L’ involuzione democratica del Paese nordafricano è infatti sinora avvenuta con il tacito benestare dell’Occidente, in cambio del ruolo di stabilizzazione che l’Egitto esercita nel quadrante mediorientale. Il patto ‘non scritto’ con l’Occidente Tale accordo è stato peraltro implicitamente confermato nel recente incontro tra al-Sisi e Trump, in cui l’ex generale ha incassato l’appoggio del magnate presidente. Tuttavia, gli attentati della domenica della Palme, che fanno seguito all’attacco alla Cattedrale di San Marco al Cairo del dicembre 2016, sono parte di un trend allarmante, che ha visto l’Egitto teatro di circa quaranta tra aggressioni ed attacchi a luoghi di culto cristiani a partire dal 2013, anno della deposizione dell’ex presidente Morsi. Washington ed i suoi alleati, sinora disposti a chiudere un occhio sulle pratiche antidemocratiche del governo al-Sisi, potrebbero ritirare presto il loro appoggio incondizionato, soprattutto se la situazione interna del Paese dovesse ulteriormente deteriorarsi. Le norme approvate dal governo egiziano sotto la comune etichetta di misure anti-terrorismo, impedendo di fatto il dialogo democratico nel Paese e riducendo drasticamente lo spazio riservato alle opposizioni e alle organizzazioni della società civile egiziana, hanno finito per esacerbare il settarismo che il presidente aveva promesso di combattere e che continua invece ad inquinare la società egiziana. La repressione controproducente La feroce repressione contro l’opposizione, specie quella di matrice islamista, sembra infatti avere fomentato la radicalizzazione del suo discorso politico. Il giro di vite operato ai danni della Fratellanza Musulmana, le incarcerazioni avvenute senza regolare processo e la violenta repressione delle manifestazioni di piazza hanno dato credito alla componente più giovane e spesso più estremista del movimento, ai danni della ‘vecchia guardia’, pacifista e non-violenta, i cui leader scampati al carcere sono ormai costretti all’esilio. Gli islamici egiziani intravedono nelle tattiche repressive dell’ex generale una chiara strategia per escluderli dall’arena politica egiziana e temono soprattutto un pericoloso ritorno agli anni di Nasser, in cui i Fratelli Musulmani erano oggetto di sistematica persecuzione. In una società così lacerata al suo interno, il sedicente Stato islamico, Isis, facendo leva sull’elemento religioso, ha gioco facile nel fomentare ulteriormente le divisioni interne, colpendo i cristiani per acquisire consensi nella comunità musulmana. I copti, che rappresentano il 10% di un Paese a stragrande maggioranza musulmana sunnita, sono stati da sempre sotto-rappresentati a livello istituzionale e hanno costantemente faticato a vedersi garantita la propria libertà di culto. I riflessi sui copti e l’arrivo di Francesco L’avvento al potere di un presidente che prometteva di garantire sicurezza e protezione ai cristiani d’Egitto era stato quindi accolto con favore dalla comunità copta. Tuttavia, i cristiani d’Egitto, che sin dall’estate 2013 sono stati additati come sostenitori di un regime oppressore e liberticida e sono stati oggetto di attacchi e rappresaglie, nutrono sempre più dubbi sulla capacità dell’ex generale di tutelarli. La visita in Egitto di Papa Francesco, che avviene quindi in una fase particolarmente delicata per gli equilibri interni del paese nordafricano, ha un valore altamente simbolico. Essa serve infatti a sottolineare la vicinanza tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa d’Egitto, nonché a portare il sostegno del pontefice in un momento così drammatico per la comunità copta e in generale per i cristiani in Medio Oriente. Soprattutto, tale viaggio costituisce un ulteriore tassello di un delicato processo di riavvicinamento al mondo musulmano che vede il pontefice impegnato in un complesso dialogo interreligioso, dopo le tensioni che avevano segnato il pontificato di Benedetto XVI. I rapporti si erano infatti quasi interrotti quando il precedente pontefice, dopo l’attentato alla comunità copta di Alessandria nella notte di capodanno del 2011, aveva denunciato il “vile gesto di morte” e aveva esortato i governi della regione ad adottare misure efficaci per la protezione delle minoranze religiose. L’uomo giusto su cui puntare? Interpretando tali dichiarazioni come un’ingerenza non richiesta, il Cairo aveva allora ritirato l’ambasciatore presso la Santa Sede e l’Università sunnita di Al-Azhar del Cairo, uno dei più autorevoli centri d’insegnamento religioso dell’islam sunnita, aveva sospeso il dialogo con la Santa Sede. Proprio l’incontro tra l’Imam di Al-Azhar, Ahmad al-Tayyb, e il Vescovo di Roma nel maggio 2016 ha rappresentato una svolta storica per un dialogo rinnovato con il mondo islamico sotto il pontificato di Francesco ed è stato l’occasione per ribadire il comune impegno per la pace ed il rifiuto di ogni forma di violenza e terrorismo. Tale incontro, peraltro, dovrebbe replicarsi in occasione della visita di Francesco in Egitto, in un momento ancor più delicato. Bergoglio, che vola al Cairo per riaprire un dialogo tra le due grandi religioni monoteiste, si troverà quindi a dialogare con al-Sisi che aveva promesso di farsi campione di un Islam moderato in contrapposizione alla visione distorta e sanguinaria promossa dall’Isis, ma le cui politiche repressive sono state sinora incapaci di fermare l’onda di attacchi che sta sfaldando il paese. Sullo sfondo, alla luce dei fatti del 9 aprile, occorre capire se Trump, e con lui l’Occidente filo-americano, ritengano ancora l’ex generale egiziano l’uomo giusto su cui puntare. Stefano Cabras, Laureato in Scienze Economiche presso l'Università di Roma Tor Vergata, concluderà in ottobre il Master in European and International Studies all'Università di Trento. Attualmente stagiare presso La Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Ue. . |
sabato 8 aprile 2017
Egitto: in attesa della visita papale
| ||||||||
 La settimana della Passione di Cristo è stata inaugurata da un tragico bagno di sangue. L’ennesimo che ha preso di mira la comunità copta egiziana (circa il 10% della popolazione), vittima di due attacchi terroristici nelle chiese di Alessandria e di Tanta. La settimana della Passione di Cristo è stata inaugurata da un tragico bagno di sangue. L’ennesimo che ha preso di mira la comunità copta egiziana (circa il 10% della popolazione), vittima di due attacchi terroristici nelle chiese di Alessandria e di Tanta.Una cinquantina i morti, oltre cento i feriti di questi attentati che, come quello avvenuto poco prima di Natale nella più grande chiesa copta del Cairo, sono stati rivendicati dai terroristi dell’autoproclamato Stato islamico. L’espansione della guerra contro i miscredenti Così facendo, i seguaci del Califfo - gli stessi che nel febbraio 2015 avevano seviziato 21 copti egiziani su una spiaggia libica - vogliono mostrare che la guerra contro i miscredenti non solo continua, ma si espande. A confermarlo sono anche i dati. Secondo il più recente report del Tahrir Insitute for Middle East Policy, nell’ultimo quarto del 2016 gli attacchi ai cristiani nel Sinai sono cresciuti in maniera esponenziale. Ed è anche per questo che da Arish, una delle località della Penisola più colpita da questi eventi di violenza settaria, è iniziato un vero e proprio esodo di famiglie cristiane, scappate in fretta e furia verso località più sicure. Mete non facili da individuare, se si considera che sin dal giorno della strage di Maspero - quando, nell’ottobre 2011, più di venti copti vennero uccisi dalle forze di sicurezza davanti alla sede della televisione pubblica egiziana - i cristiani accusano il governo di non essere in grado di proteggerli. Accuse che il presidente Abdel Fattah Al-Sisi non solo respinge, ma cerca anche di nascondere. Se a Natale, la televisione nazionale aveva mandato in onda le immagini in diretta dal luogo della strage con una musica di sottofondo che copriva le grida di protesta dei copti, lunedì l’edizione del giornale Al-Bawaba che riportava le critiche dei cristiani al sistema di sicurezza egiziano è stato ritirato dal commercio. Al-Sisi e le promesse di sicurezza tradite Il duplice attentato di domenica è infatti un colpo grosso ad Al-Sisi e alle sue promesse. Non solo quella di proteggere i cristiani e la chiesa copta - che ha sostenuto il golpe grazie al quale i militari sono tornati al potere –, ma anche quella di garantire sicurezza e stabilità all’intero Paese e alla regione. È con queste promesse che Al-Sisi ha cercato di legittimarsi e accreditarsi agli occhi del mondo, descrivendo il suo Egitto come la pedina stabilizzatrice della regione. Eppure, se si guarda a quanto sta accadendo lungo il Nilo da quando i militari hanno ripreso il potere, emerge un quadro diverso, ovvero l’immagine di un Paese dove la repressione dell’opposizione, in primis quella di matrice islamista, ha portato a un’escalation di atti di terrore. Gli attacchi di matrice jihadista tradizionalmente concentrati nella penisola del Sinai hanno preso di mira località urbane. Se nel 2013, fuori dal Sinai si erano contati 261 attentati, nel 2016 si è arrivati vicino a quota 700. Ecco perché molti analisti temono che la situazione egiziana possa degenerare, seguendo ad esempio quanto già avvenuto in Algeria dopo l’intervento militare del 1991. All’epoca, la repressione del fronte islamista risultato vincitore delle elezioni portò allo scoppio di una guerra civile che durò un intero decennio. Il viaggio di Bergoglio al Cairo Questa evoluzione intimorisce quanti si stanno preparando ad accogliere papa Bergoglio che a fine mese atterrerà al Cairo non solo per incontrare il suo omonimo ortodosso, ma anche per vedere Al-Sisi, uomo che negli ultimi anni ha cercato di descriversi come il Lutero dell’Islam, ovvero il portatore di un pensiero musulmano riformato e mediano, lontano dall’estremismo dell’autoproclamato Stato islamico. Anche in questo però, Al-Sisi sembra fallire, come mostrano le recenti frizioni tra lui e Al-Azhar, massima autorità dell’Islam sunnita che dopo aver sostenuto l’ascesa del generale, ha recentemente criticato diverse sue decisioni - in primis quella dell’omologazione dei sermoni del venerdì. Sarà quindi interessante osservare come papa Bergoglio si inserirà in questo dibattito, direttamente connesso con quello della libertà religiosa e della costruzione dei luoghi di preghiera (moschee e chiese), da sempre questione alla radice di molti scontri settari. Anche se lo scorso anno il governo egiziano ha approvato una storica legge che regola la costruzione delle chiese, sono ancora molti i cristiani che non la ritengono risolutiva. Lo stato di emergenza nell’epoca di Al-Sisi Il viaggio di papa Bergoglio non è l’unica cosa da tenere d’occhio dopo i recenti attentati. L’evoluzione all’interno del Paese sarà influenzata anche dall’imposizione dello stato di emergenza, annunciato all’indomani della strage dal presidente. Sinai a parte - dove da oltre tre anni lo stato di emergenza viene rinnovato di volta in volta - sarà la prima volta che questo verrà applicato, dopo l’adozione della Costituzione del 2014 che ha limitato i poteri del presidente durante questi periodi eccezionali, introducendo una serie di procedure istituzionali necessarie alla dichiarazione dello stato di emergenza. Nel giugno 2013, ovvero quando al potere c’era ancora il presidente Mohammed Morsi, la Corte Costituzionale dichiarò incostituzionali alcuni aspetti della legge sullo stato di emergenza, soprattutto quelli relativi alle prerogative del presidente e ai tribunali speciali creatisi in queste occasioni. Nei fatti però, fino ad ora queste modifiche sono rimaste solo parole che non hanno trovato applicazione pratica. Sarà quindi interessante vedere come i recenti attentati alla comunità copta influenzeranno, nella prassi, la giurisprudenza egiziana. Solo così si capirà che cosa vuol dire, praticamente, vivere sotto lo stato di emergenza nell’epoca di Al-Sisi. Viola Siepelunga è giornalista freelance. |
lunedì 20 marzo 2017
Egitto: verso l'intolleranza religiosa
| ||||||||
 Si stima che i copti d’Egitto costituiscano il 10% della popolazione del Paese, nonché la più grande popolazione cristiana di tutto il Medio Oriente: tale minoranza, tuttavia, è stata per lunghi anni oggetto di una costante discriminazione da parte delle istituzioni e, seppur non in maniera onnicomprensiva, della società egiziana stessa. Si stima che i copti d’Egitto costituiscano il 10% della popolazione del Paese, nonché la più grande popolazione cristiana di tutto il Medio Oriente: tale minoranza, tuttavia, è stata per lunghi anni oggetto di una costante discriminazione da parte delle istituzioni e, seppur non in maniera onnicomprensiva, della società egiziana stessa.Per questa ragione, la recente serie di attacchi rivendicati dall’Isis (il sedicente Stato islamico, anche noto come Daesh) ai danni dei copti nel Sinai non giunge certamente come una novità. A dire la verità, un sedimentato e violento antagonismo tra le diverse comunità del Sinai, culminato in diversi omicidi di predicatori cristiani negli anni passati, si era già registrato tempo prima che l’organizzazione salafita-jihadista Ansar Bait al-Maqdis decidesse di divenire una delle province (Wilayat) dell’autoproclamato Califfato di Abu Bakr al-Baghdadi, nel novembre del 2014. Nonostante questo, durante l’ultimo mese la situazione sembra esser ulteriormente precipitata: sette egiziani-cristiani sono stati assassinati, molti freddati con un colpo alla nuca, nella città di El-Arish, capoluogo della provincia del Sinai. Rivendicati dall’Isis, questi omicidi fanno seguito ad un aumento delle minacce ed intimidazioni subite da molte famiglie di copti abitanti nel Sinai egiziano. Se nel 2011 la comunità di copti nell’area ammontava a circa 5.000 persone, ad oggi ne rimangono meno di 1.000, secondo fonti locali. Il peggiorare della situazione Alle condanne arrivate da molte località ed esponenti religiosi - sia cristiani che musulmani - fa ora seguito un monito d’allarme. Mentre in Siria ed Iraq l’Isis continua a perdere terreno, si teme che l’organizzazione terroristica aumenti le proprie azioni sovversive, minando i già delicati rapporti intra-religiosi e settari nella regione e mirando a dare ulteriore respiro alla tesi dello scontro tra civiltà. Sono infatti quaranta i copti d’Egitto che hanno perso la vita per mano dell’organizzazione jihadista negli ultimi tre mesi. Di questi, venticinque sono morti nell’attentato suicida dello scorso dicembre ad una cattedrale copta del Cairo rivendicato dall’Isis, il quale ha lasciato a terra prive di vita molte donne e bambini, spingendo l’Economist ad affermare in maniera perentoria che ciò che sta prendendo piede in Egitto è un vero e proprio massacro ai danni della popolazione cristiana. Il timore scaturito da questi attacchi, coadiuvato ed accentuato da un video diffuso dall’Isis stesso nel quale si minacciano apertamente i copti di rappresaglie, ha esacerbato il già fragile senso di sicurezza della minoranza cristiana, causando l’esodo di oltre 250 famiglie verso altre province del paese. Il generale al-Sisi il grande assente Il grande assente nel racconto sino ad ora proposto è il generale al-Sisi, che entra all’interno dell’equazione come un elemento che, secondo Amnesty International, sarebbe almeno indirettamente responsabile di tali brutali azioni. Il dittatore, nel corso degli ultimi anni, non ha soltanto fallito nel proteggere l’integrità sociale ed il benessere economico della minoranza cristiana, sia nel Sinai sia in tutto il territorio egiziano - rendendola bersaglio vulnerabile di attacchi, intimidazioni e rapimenti -, ma ha negligentemente evitato di perseguire giuridicamente i responsabili delle violenze settarie perpetrate ai loro danni nonché di garantire un contesto securitario effettivo a fare si che tali azioni cessassero, adottando politiche inefficienti e contro-producenti. La marginalizzazione del Sinai Gli abitanti della regione del Sinai vivono da lunghi decenni una condizione di esclusione: il territorio, sotto occupazione israeliana tra il 1967 e il 1982, anno nel quale venne completato il ritiro Israeliano dopo gli accordi di pace con l’Egitto del 1979, non ha infatti mai beneficiato dell’investimento governativo necessario allo sviluppo. Inoltre, a rendere quest’area geografica di difficile gestione, è anche la sua stessa morfologia: il territorio è desertico, vasto, poco abitato e difficile da controllare. Per la sua quasi totale impermeabilità, esso ricalca gli sconfinati territori che rivestono la fascia saheliana. Nel corso degli anni, a causa della marginalizzazione economica delle comunità beduine, si sono affermate nuove forme di sostegno basate su traffici illeciti, da quello di uomini a quelli di stupefacenti ed armamenti. La difficile situazione socio-economica in Egitto è andata peggiorando dall’inizio della Primavera araba, portando ulteriore sconforto nelle zone già deprivate del Sinai. In seguito al colpo di stato del generale al-Sisi, e alla conseguente violenta repressione ai danni dei Fratelli Mussulmani, il Sinai è divenuto luogo di ritrovo per varie correnti islamiste e del salafismo-jihadista. Nel Sinai infatti è da anni in corso una sanguinosa campagna militare che vede le forze di sicurezza e l’esercito egiziano battersi con vari gruppi armati, alcuni dei quali hanno apertamente annunciato la loro affiliazione all’Isis. L’approccio militare fallimentare del regime Nella penisola del Sinai si è oggi davanti ad una vera e propria low-intensity insurgency, dove il potere delle autorità centrale del Cairo risulta essere limitato e inefficace, costringendo la popolazione locale a essere sempre più isolata ed abbandonata al proprio destino. Da una parte infatti, gli abitanti si trovano a dovere fare i conti con il pugno duro dell’esercito egiziano e con le sue politiche militarizzate, dall’altra vengono costantemente minacciati dai vari gruppi armati attivi nella zona. La storia della lotta al terrorismo ci insegna che combattere il terrore con il terrore, oltre ad essere moralmente reprensibile, risulta essere del tutto inefficace. La politica militarizzata di al-Sisi, rischia infatti di portare a un inasprimento delle divisioni, con annesse tensioni in una regione sensibile e tutt’altro che indifferente dal punto di vista strategico. Più che risolvere il problema della stabilità del Sinai, il governo centrale egiziano ha esacerbato la tensione tramite l’adozione di politiche inefficaci alimentando un ulteriore stato di malcontento, figlio di una politica che, sino ad ora, è stata caratterizzata dal pugno di ferro contro gli islamisti, sia egiziani che all’estero: pensiamo agli jihadisti nel Sinai, ai Fratelli Musulmani, a Hamas o al sostegno alle forze anti-islamiste del generale Haftar in Libia. Ciò riflette un trend tuttavia globale: dal Cairo, a Tel Aviv, sino ad arrivare a Washington con la nuova Amministrazione Trump, sembra non esserci nessuna differenziazione nell’approccio verso le varie organizzazioni islamiste. Nel chiudere le porte alle frange più moderate dell’Islam politico o, ancora peggio, addossare ad un’intera religione le colpe per le azioni violente di alcuni, si indeboliscono quelle stesse comunità e organizzazioni che rappresentano il principale baluardo contro la radicalizzazione. L’Isis nel Sinai egiziano In un video uscito nelle ultime settimane, l’Isis ha definito I Copti d’Egitto la loro “preda preferita”. Il motivo di simili esternazioni è spesso da ricercare nell’attenzione mediatica - linfa vitale per Daesh - che i gruppi terroristici desiderano ottenere nel circuito dell’intrattenimento occidentale. Difatti, è proprio da tale comportamento che essi riescono ad acquisire numerosi benefici: dall’affermazione del loro status, alla possibilità di attirare aspiranti jihadisti, alla rigida affermazione della retorica cara al sedicente Stato islamico - ma anche al neo-presidente statunitense - dello scontro tra civiltà, tramite la quale veicolano divisione per trarre legittimazione. Tutto questo dovrebbe essere un campanello d’allarme per l’Europa: l’Egitto infatti, sotto numerosi punti di vista, rimane oggi sull’orlo del baratro (da quello economico a quello securitario) e un collasso del paese comporterebbe ripercussioni regionali e internazionali devastanti: eppure, questo aspetto viene raramente posto al centro di un dibattito produttivo. A farne le spese di ciò è, per prima, la comunità Copta d’Egitto, già decimata da anni di discriminazione e marginalizzazione, ma presto potrebbe esserlo tutta Europa, Israele ed il resto della regione. Dopo Iraq, Siria, Yemen, Libia in macerie, un collasso in Egitto sarebbe irreparabile e potrebbe concretamente innescare l’ennesimo vortice vizioso di violenza e conflitto, caratteristiche fastidiosamente onnipresenti in ogni esemplare di Stato debole e/o fallito. Andrea Dessì è Ricercatore nel Programma Mediterraneo e Medioriente, IAI; Ludovico De Angelis studia Relazioni Internazionali e sta attualmente effettuando un tirocinio presso lo IAI (@__Ludovico). | ||||||||
venerdì 17 marzo 2017
Libia: il groviglio si aggroviglia ancora
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iscriviti a:
Post (Atom)