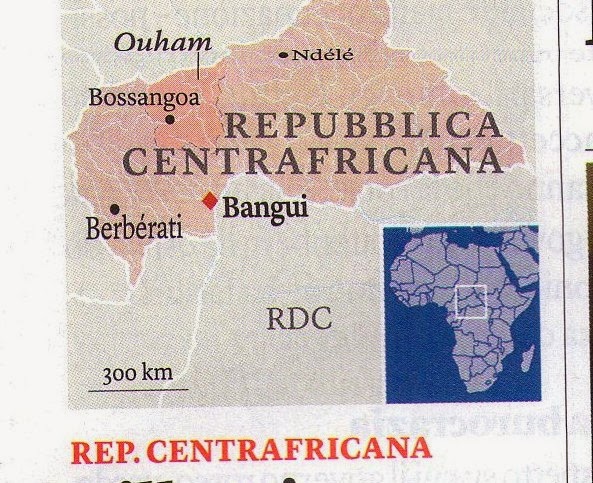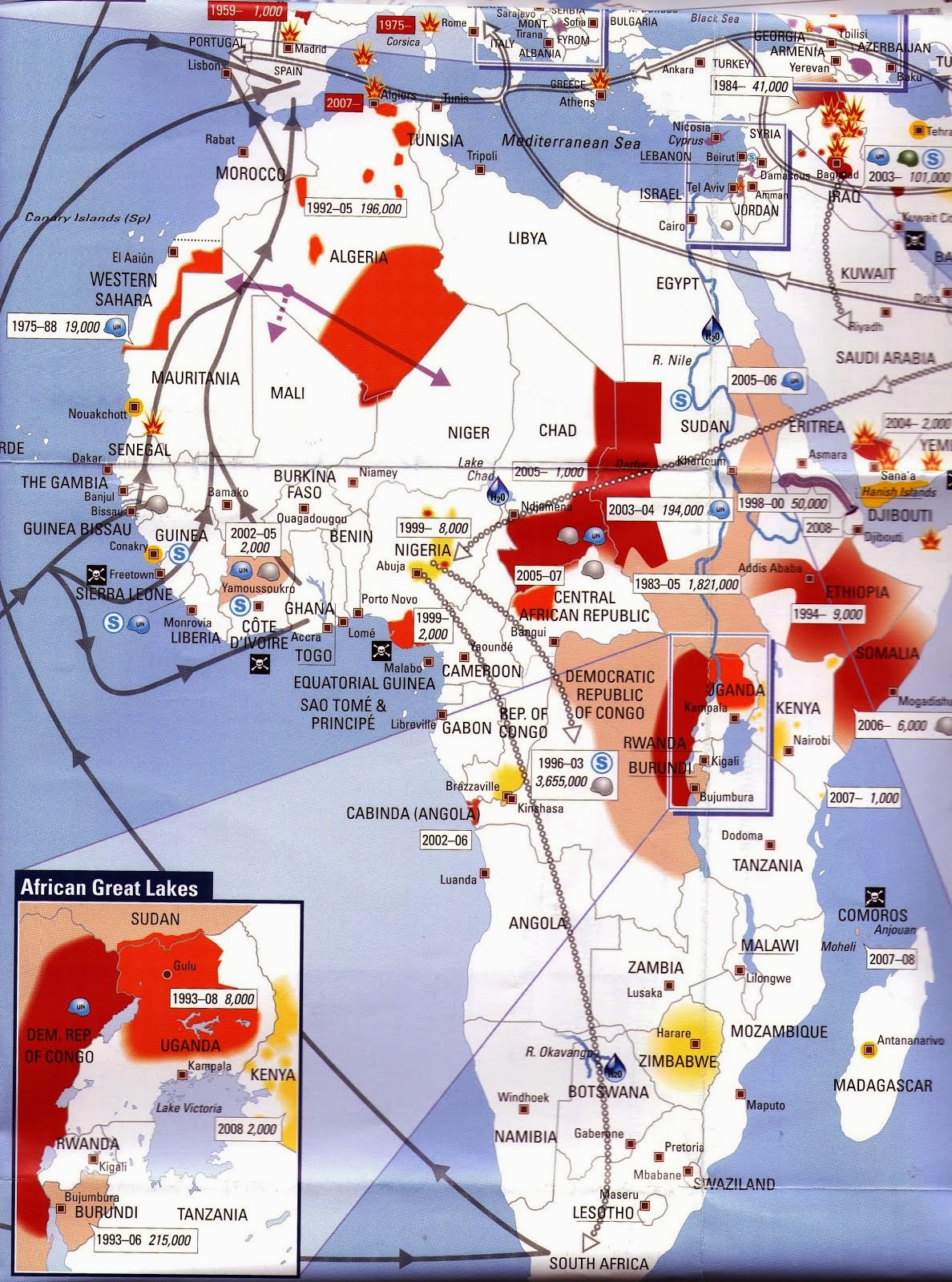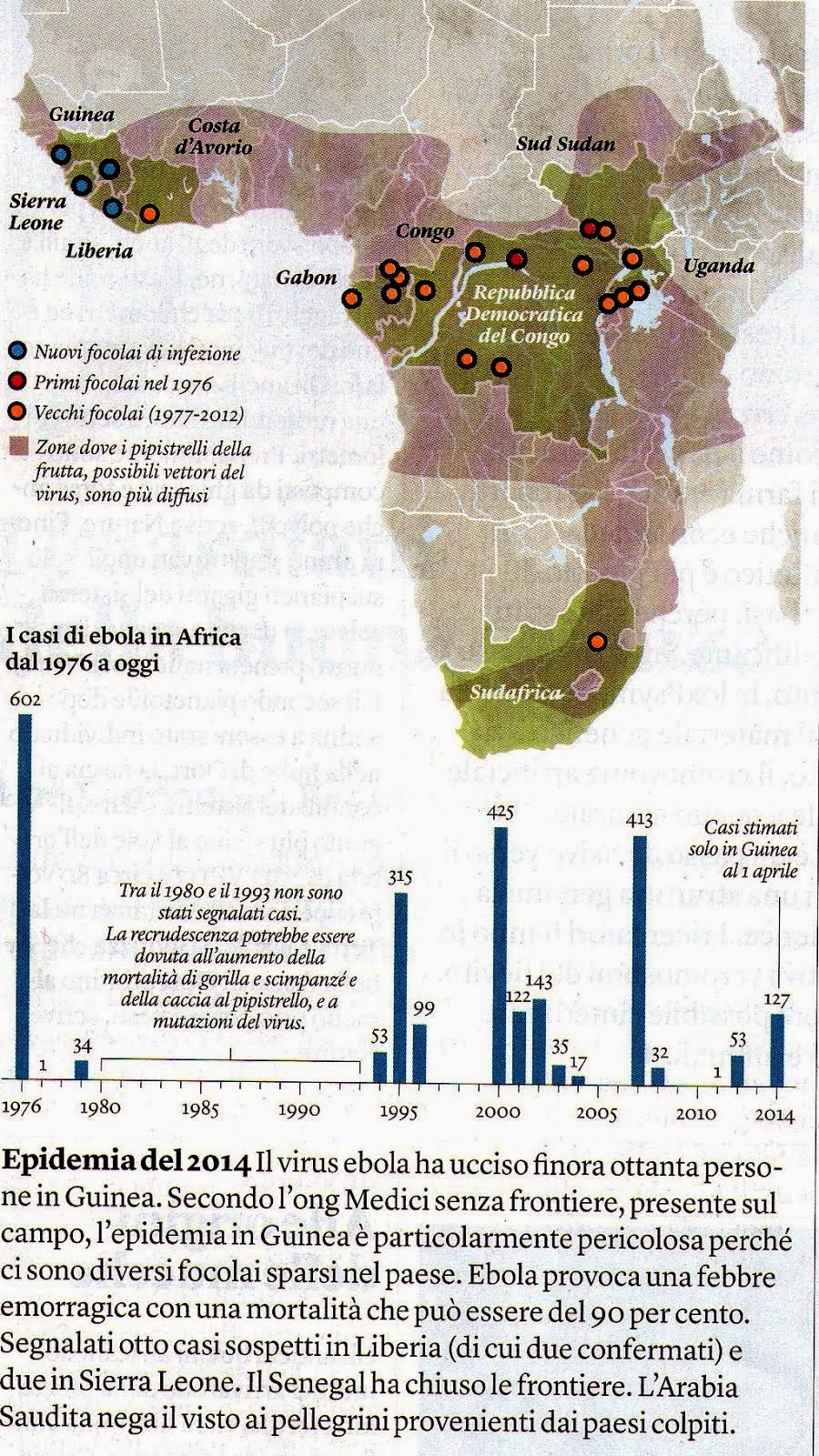venerdì 27 novembre 2015
venerdì 20 novembre 2015
Nord Africa: un quadro allarmannte
| Libia, Egitto, Algeria Stato islamico in Nord Africa: rivalità e alleanze Umberto Profazio 31/08/2015 |
|
 Complice la situazione di estrema instabilità in Libia, l’avanzata del terrorismo di matrice jihadista in Nord Africa non sembra conoscere soste.
Complice la situazione di estrema instabilità in Libia, l’avanzata del terrorismo di matrice jihadista in Nord Africa non sembra conoscere soste.Nella prima metà di agosto il gruppo terrorista dello Stato Islamico si è gradualmente impadronito della città libica di Sirte, provocando nuovi timori sia da parte delle principali potenze regionali, sia da parte delle diplomazie occidentali.
Il 20 agosto un attacco nella periferia di Sousse, in Tunisia, ha provocato la morte di un poliziotto. Il giorno stesso un’autobomba è esplosa di fronte a un edificio di proprietà delle forze di sicurezza egiziane nel distretto di Shubra el-Kheima, nella periferia del Cairo, toccando anche il tribunale adiacente e provocando 29 feriti. Gli episodi si susseguono ravvicinati.
Lo Stato Islamico e al-Mourabitun
Nonostante la maggior parte degli attentati sia stata attribuita agli uomini di Abu Bakr al-Baghdadi, la realtà sembra essere molto più complessa. Il fronte del terrore in Nord Africa non è compatto e monolitico come a prima vista potrebbe sembrare, ma nasconde una ricca diversità di posizioni.
Questo è quanto si può desumere dall’annuncio con cui il 24 agosto i miliziani dello Stato Islamico hanno chiesto la testa di Mokhtar Belmokhtar, a capo del gruppo terroristico al-Mourabitoun.
Conosciuto per il tragico attacco del gennaio 2013 presso l’impianto di gas algerino di In-Amenas, al-Mourabitoun è nato dalla fusione tra le Brigate al-Mulathameen e il Movimento per l’unità del Jihad in Africa occidentale.
Le origini qaediste della formazione si desumono dal fatto che le Brigate al-Mulathameen furono create da Belmokthar come una fazione dissidente di al-Qaeda nel Maghreb islamico. Tuttavia la scissione non è stata così profonda da fare rinnegare a Belmokhtar la sua appartenenza a al-Qaeda.
Nonostante il 15 maggio Adnan Abud Walid Sahraoui, capo della branca saheliana dell’organizzazione, abbia prestato giuramento di fedeltà allo Stato islamico, sono arrivate subito le smentite.
Il 17 luglio al-Mourabitoun ha rinnovato la sua bay’ah (sottomissione) a Ayman al-Zawahiri, dichiarando di rappresentare al-Qaeda in Africa occidentale e di continuare la sua battaglia contro la Francia e i suoi alleati.
L’organizzazione ha anche ribadito la leadership di Belmokhtar, smentendo così le notizie relative alla sua uccisione in un raid condotto dall’aviazione statunitense a Ajdabya a giugno.
La natura saheliana di al-Mourabitoune la scelta dell’Algeria quale teatro principale delle sue azioni, sembra rappresentareun ostacolo all’espansione dello Stato islamico in questo Paese.
Soprattutto a seguito della repressione degli uomini di al-Baghdadi da parte delle forze di sicurezza algerine: nel dicembre 2014, infatti, i militari di Algeri sono riusciti a annientare il gruppo Jund al-Khilafa, affiliato allo Stato islamico, eliminando anche il suo presunto capo Abdelmalek Gouri.
I dissidenti di Ansar Beit al-Maqdis
In questo quadro estremamente dinamico, risulta naturalmente importante il teatro egiziano, dove la minaccia principale deriva da Ansar Beit al-Maqdis, formazione originariamente di stanza nel Sinai che negli ultimi mesi ha allargato il suo raggio di azione.
Nonostante la sua bay’ah allo Stato Islamico e la ridenominazione in Wilyat Sinai, il processo di affiliazione è stato dibattuto, con alcuni membri che hanno preferito abbandonare il gruppo e prendere altre strade.
Tra questi un’importanza fondamentale sembra avere Hisham Ali Ashmawy, che s’è meritato anch’egli l’inserimento nella lista dei ricercati da parte dello Stato islamico.
Ritenuto dalle autorità del Cairo responsabile dell’uccisione il 29 giugno del procuratore generale Hisham Barakat, Ashmawy infatti avrebbe partecipato alle operazioni contro lo Stato islamico nella città libica di Derna, allineandosi alle posizioni del Mujhaideen Shura Council.
Le indagini sugli attentati in Tunisia
Ancora più complesso sembra essere il panorama tunisino. Lo Stato islamico ha infatti rivendicato i principali attentati nei Paese, compresi quelli del museo del Bardo del 18 marzo e dell’Imperial Marhaba Beach Hotel di Sousse del 26 giugno.
In un primo momento le autorità tunisine sono sembrate riluttanti a attribuire la responsabilità di entrambi gli attacchi allo Stato islamico. Le indagini per l’attentato del Bardo si erano indirizzate sulla pista delle Brigate Okba Ibn Naafa, gruppo qaedista attivo soprattutto nella regione montuosa del Chembi, al confine con l’Algeria.
Solo a seguito dell’inchiesta della polizia britannica, è emerso un collegamento diretto tra l’attacco del Bardo e quello di Sousse: si ritiene infatti che i responsabili di entrambi gli attacchi siano passati dal medesimo campo di addestramento di Sabratha in Libia. Presumibilmente nello stesso periodo.
Un’ulteriore complicazione deriva dal fatto che il campo di Sabratha è notoriamente gestito da Ansar al-Sharia in Libia, il cui rapporto con lo Stato islamico risulta ambivalente. Nonostante tale formazione non abbia mai fatto voto di sottomissione a al-Baghdadi, pare che molti dei suoi ex membri siano successivamente entrati nelle file dello Stato islamico, rafforzando l’organizzazione.
Una libertà di movimento assoluta
In un contesto caratterizzato da scarsa trasparenza, inaffidabilità delle fonti e strumentalizzazioni politiche, l’unica certezza è che il fattore complessità sembra avvantaggiare lo Stato islamico.
Facendo del Nord Africa un’immensa Siria dove l’assenza di una componente settaria in grado di infervorare gli animi viene compensata da un’incredibile pluralità di attori, tutti con differenti agende e caratterizzati da un’irriducibile rivalità. E i cui movimenti vengono agevolati dall’assoluta mancanza di controlli alle frontiere.
A metà agosto il valico di Musaid tra Libia e Egitto è rimasto sguarnito, per un immotivato ritiro delle guardie di frontiera libiche. E a Sirte si stanno moltiplicando le notizie relative alla presenza di numerosi combattenti nigeriani tra le fila dello Stato islamico.
Questo presunto afflusso, tramite le porose frontiere tra Nigeria e Niger e tra quest’ultimo e la Libia, dà un contenuto concreto alla bay’aha al-Baghdadi annunciata dall’organizzazione nigeriana nei mesi scorsi.
Nella non più remota eventualità di un intervento in Libia (sia da parte occidentale che della Lega Araba), il controllo delle frontiere assume un’importanza sempre più cruciale e decisiva.
Umberto Profazio è dottorando in Storia delle Relazioni Internazionali presso l’Università di Roma “Sapienza” e analista per la Nato Defence College Foundation. Il suo primo e-book “Lo Stato Islamico: origini e sviluppi” è edito da e-muse.
mercoledì 18 novembre 2015
Libia: siamo alla impotenza
Libia: aspettando l’accordo come Godot o agire Giuseppe Cucchi 28/08/2015 |
|
 Nella primavera del 1944 l'Unione Sovietica, esasperata dalla lunga, e sino a quel momento vana, attesa dell'apertura di un secondo fronte alleato in Europa che allentasse la pressione esercitata dalla Germania verso Est, scriveva su uno degli organi di stampa di regime "Ci sono due strade per un simile intervento.
Nella primavera del 1944 l'Unione Sovietica, esasperata dalla lunga, e sino a quel momento vana, attesa dell'apertura di un secondo fronte alleato in Europa che allentasse la pressione esercitata dalla Germania verso Est, scriveva su uno degli organi di stampa di regime "Ci sono due strade per un simile intervento.La prima è quella naturale che prevede la discesa dall'alto dei cieli dell'Arcangelo Michele con la sua spada fiammeggiante. La seconda è quella sovrannaturale, che troverebbe espressione in uno sbarco di forze Usa e del Commonwealth nei Paesi Bassi o nel Nord della Francia".
Una valutazione surreale che però, fatti i dovuti adeguamenti, ben si adatta anche a quanto sta avvenendo in questo momento in area libica, dando con precisione l'idea di quale sia stato sino ad ora in questa crisi il comportamento di alcuni Paesi che dovrebbero essere fra i più grandi del mondo.
Paesi che, posti di fronte ad un incendio che divampa alle porte di casa, sono capaci soltanto di lanciarsi in sterili esortazioni, perennemente basate sulla speranza che alla fine sia qualcun altro ad impegnarsi, pagando di tasca propria ogni eventuale conto e rischiando di sporcarsi le mani in ciò che la lunga inerzia internazionale ha permesso divenisse un terribile pantano di lotta fra fazioni.
La lezione della ex Jugoslavia
Certo, la ricerca di una soluzione negoziale è auspicabile in ogni crisi, qualsiasi siano la sua entità e le sue dimensioni. Altrettanto certo è il fatto che eventuali canali di dialogo fra le parti debbano essere mantenuti aperti anche nei momenti in cui le armi fanno sentire con maggiore intensità la loro voce.
Nel contempo però è irenicamente assurdo sperare che tutti i contenziosi possano trovare una accettabile soluzione intorno ad un tavolo di trattative.
Se ci si lascia guidare da questa idea si rischia di non concludere nulla e di ritrovarsi domani con una crisi ancora da risolvere ma approfondita e peggiorata dal trascorrere del tempo. E non si tratta della peggiore delle possibili ipotesi, considerato come il volere raggiungere un accordo a tutti i costi possa magari indurre le parti a concordare su tregue o paci talmente insostenibili da portare in sé i germi di future, peggiori catastrofi.
In particolare, come tra l'altro in tempi relativamente recenti ci hanno tragicamente dimostrato le guerre della dissoluzione jugoslava, ogni crisi ha un suo preciso momento di culmine superato il quale il bilancio di sangue versato è divenuto tanto pesante, e gli odi reciproci così profondi, che diviene inutile sperare che le parti possano accettare di aprire un dialogo e condurlo avanti, più o meno autonomamente, sino ad un accordo.
Il dialogo, se dialogo ci sarà, potrà soltanto essere imposto dall'esterno, da altri protagonisti più forti, disposti ad impegnarsi in prima persona per costringere, sorvegliare, garantire.
È il ruolo che nella catastrofe jugoslava hanno svolto gli Stati Uniti, riuscendo a tirarsi dietro sotto le bandiere della Nato anche buona parte di una Unione europea (Ue) i cui sforzi si erano limitati sino a quel momento a sagge esortazioni alla ragione, tanto ripetute quanto vane.
Interventi diplomatici internazionali ‘leggeri’
Nella crisi libica siamo ancora palesemente a quel medesimo stadio, nonostante il fatto che la situazione sull’altra sponda del Mediterraneo divenga di giorno in giorno più complicata e pericolosa, con l'Isis che potrebbe a breve scadenza dilagare a macchia d'olio da Sirte e che già ora costella di focolai di infezione tutti i paesi vicini, primo fra tutti l'Egitto.
Di fronte a simili dati di fatto che cosa possiamo mettere sul tavolo? Una iniziativa delle Nazioni Unite, affidata oltretutto non a una personalità di spicco che potrebbe conferirle l'adeguato peso politico ma ad un diplomatico spagnolo bravo quanto si vuole ma estremamente leggero sul piano della considerazione internazionale.
Non c'è così da stupirsi se l'esercizio diplomatico ha finito col trasformarsi in una ripetitiva e sterile partita di ping-pong fra il governo di Tobruk e quello di Tripoli, impegnati a rimpallarsi in eterno accuse e responsabilità.
Alla mediazione delle Nazioni Unite s’è aggiunta di recente "l'esortazione" alle parti promossa dal ministro degli Esteri italiano Paolo Gentiloni. Iniziativa certamente lodevole - cui hanno subito aderito alcuni fra i maggiori protagonisti della scena internazionale, ben contenti di avere trovato il modo di poter dire domani "Ho tentato di fare qualcosa!" -, ma che rischia di essere completamente inutile se non verrà integrata a breve scadenza da misure concrete e decisive.
Così come essa è ora, l'iniziativa ricorda infatti soltanto l'esortazione che San Filippo Neri rivolgeva ai bambini del suo oratorio: "Buoni, state buoni … se potete!". No, questi bambini libici sono bambini che per il momento proprio non possono stare buoni!
Che cosa possiamo fare? Alternative
Ritorna quindi, insistente e sino ad ora pressoché totalmente inevasa, la domanda "Che cosa possiamo fare"? E soprattutto che cosa può fare l'Italia, un Paese che è in prima fila per ciò che riguarda gli elementi di danno e di rischio connessi alla crisi, ma che nel contempo assolutamente non dispone della forza necessaria a farvi fronte da sola?
Al di là della tentazione di far tintinnare le sciabole, che sempre più spesso si individua nell'ambito di alcuni settori della nostra politica e dei nostri mass media, da ogni equilibrata valutazione emerge infatti con impressionante chiarezza come un eventuale nostro sforzo in senso militare potrebbe concretizzarsi al massimo nell'invio in area di una forza composta da un totale di 10/15 mila uomini: 15 nel caso in cui lo sforzo dovesse essere di breve durata, 10 se esso fosse destinato a prolungarsi nel medio e lungo termine.
Una disponibilità tanto esigua di forze rende indispensabile per l'azione la costituzione di una qualsiasi forza multinazionale di dimensioni adeguate. Il che significa muoversi sotto una delle tre bandiere possibili, vale a dire in primo luogo quella delle Nazioni unite, poi quella della Nato ed infine quella della Ue.
Non possedendo né la leadership degli americani né la disinvoltura neo colonialista della Francia non possiamo infatti pensare a ‘coalitions of the willings’ cui possano associarsi, sollecitati da una nostra iniziativa, altri Paesi dell'area mediterranea dotati, essi sì, di forze militari di entità sufficiente a configurare una forza di peacekeeping credibile. Il riferimento è chiaramente all'Egitto e alla Algeria, minacciati quanto noi e per molti aspetti più di noi dalla crisi libica.
Non subordinare l’azione al consenso libico
Perché esista domani una forza di peacekeeping - anzi per essere precisi di peaceenforcing! - destinata ad operare nel Paese occorre però che sin da oggi qualcuno inizi a proporne la costituzione nelle sedi dovute, chiarendo tra l'altro che essa dovrebbe comunque essere messa in piedi indipendentemente da quell'assenso congiunto dei due governi di Tobruk e di Tripoli, entrambi per molti versi illegittimi, che potrebbe in futuro venire o più probabilmente non venire.
È tempo quindi che l’Italia inizi a muoversi in quella direzione, cercando magari di dare forza alla sua voce con il tentativo di imporre la sicurezza europea come un unicum inscindibile che renda impossibile separare ciò che avviene in questo momento a nord est, in Ucraina ed ovunque i nostri interessi contrastino con quelli russi, con quanto sta succedendo a sud, dall'altro lato di quel mare Mediterraneo che in questo particolare periodo storico unisce ed accomuna molto più di quanto non separi.
A corollario e a premessa, come più volte già indicato in sedi autorevoli ma mai realizzato, occorrerebbe cercare di tagliare i cordoni finanziari che ancora alimentano le fazioni in lotta permettendo loro di perpetuare gli scontri.
Tagliare i cordoni finanziari
Una operazione quanto mai difficile, che da un lato richiederebbe adeguate pressioni politiche sui vari sponsor dei combattenti, un elenco molto lungo che coinvolge buona parte del mondo arabo, e non soltanto di quello.
D'altro canto, invece, su scala nazionale, bisognerebbe costringere l'Eni a cercare altrove fornitori sostitutivi della aliquota di idrocarburi per cui ancora dipendiamo dalle forniture della Libia, interrompendo così oltre al flusso di petrolio e gas verso l’Italia, anche quel continuo flusso di valuta che dall'Italia raggiunge la Banca centrale libica, organismo preposto a smistarlo poi in maniera equilibrata fra tutte le parti in lotta.
Un flusso la cui esistenza fa sì che gli italiani possano essere annoverati non solo fra le maggiori vittime, ma altresì fra i maggiori responsabili del perdurare di questa crisi.
Per quanto grandi possano apparire le difficoltà, bisogna quindi tentare di agire, essendo pronti se necessario ad adottare soluzioni imperfette e pericolose e sapendo che spesso bisognerà scegliere il male minore e turarsi eventualmente il naso accettando se indispensabile alleati per molti versi discutibili.
Il tutto nella piena consapevolezza del fatto che il tempo gioca contro di noi e ci obbligherà quindi, qualora decidessimo di impegnarci, ad adottare tutta una serie di quelle "decisioni sul tamburo" che le grandi democrazie hanno sempre difficoltà a concepire ed accettare.
Ci sono soluzioni alternative? Sì, forse quella di attendere anche noi la discesa dal cielo di un Arcangelo Michele armato di spada fiammeggiante e disposto a risolvere tutti i nostri problemi!
Giuseppe Cucchi, Generale, è stato Rappresentante militare permanente presso la Nato e l’Ue e Consigliere militare del Presidente del Consiglio dei Ministri.
martedì 10 novembre 2015
Libia: l'onu e l'accordo zoppo
Iscriviti a:
Post (Atom)