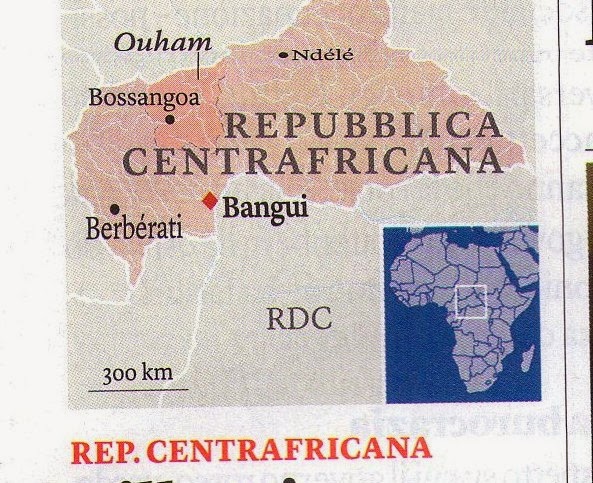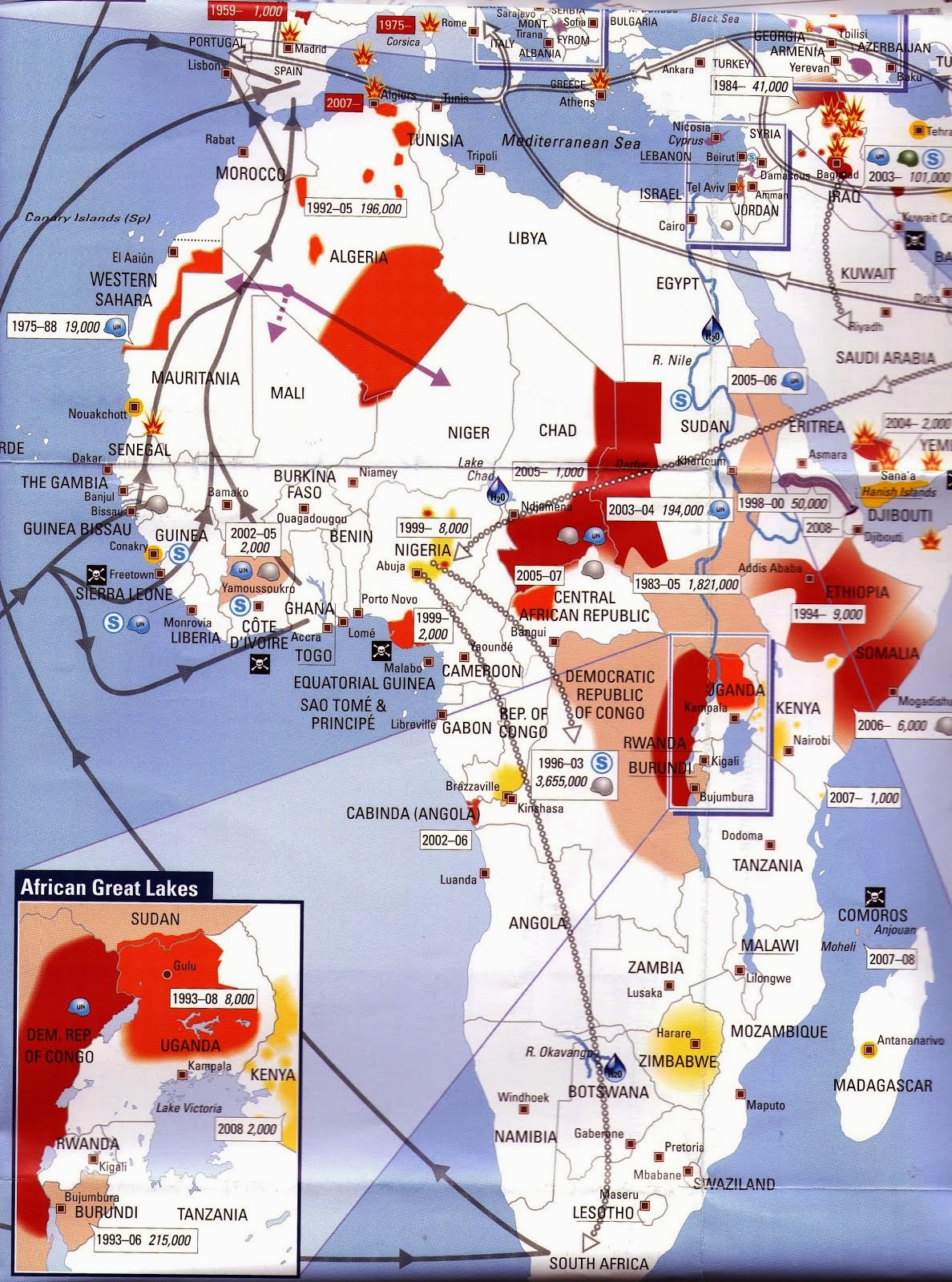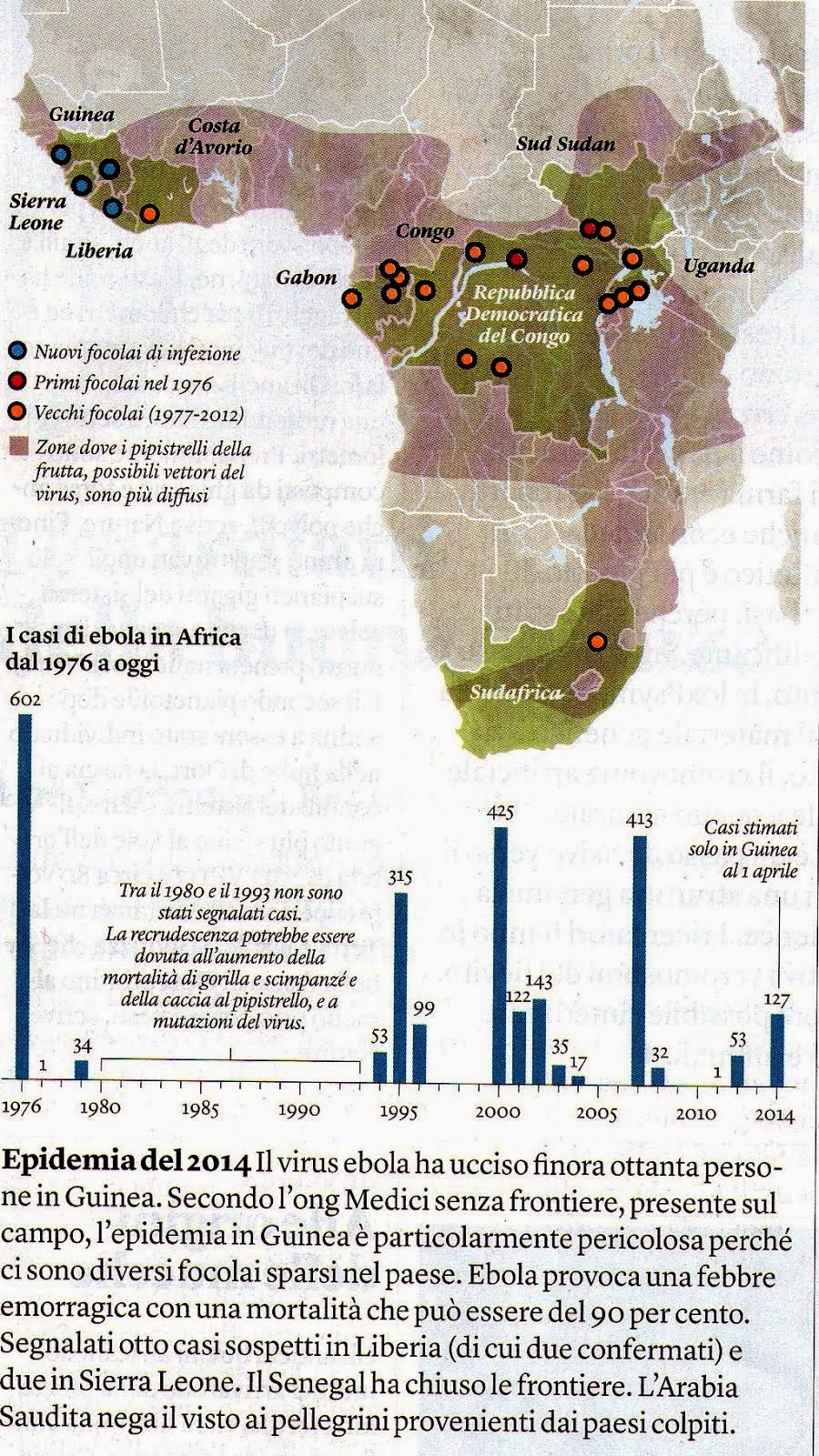lunedì 29 settembre 2014
Uganda: l'insorgenza è in ripresa
Lo scorso 6 luglio un gruppo
di uomini armati non meglio identificati ha attaccato alcune postazioni di
polizia e caserme nei distretti ugandesi di Kasese, Ntoroko e Bundibugyo, al
confine con la Repubblica Democratica del Congo (RDC), provocando la morte di
58 persone (41 assalitori e 17 tra poliziotti e civili). Sebbene l’attacco non
sia stato rivendicato, sono forti i sospetti che la responsabilità sia del
gruppo ugandese ADF-Nalu, nato dall’unione delle Forze Democratiche Alleate
(ADF) e dall’Esercito Nazionale per la Liberazione dell’Uganda (NALU) e
costituito per la maggior parte da miliziani islamici affiliati alla setta
Jammaat Tabligh. La ripresa dell’insorgenza di ADF-Nalu, che ha a lungo
sfruttato le province orientali del Congo come retroterra per i propri attacchi,
costituirebbe una seria minaccia alla sicurezza di Kampala, poiché il gruppo
agisce in funzione antigovernativa ed è riuscito progressivamente a canalizzare
il forte malcontento delle comun! ità musulmane più deboli e marginalizzate. A
suscitare forte preoccupazione è la possibilità di una graduale infiltrazione
di ADF-Nalu da parte di elementi del network jihadista regionale, in
particolare miliziani del gruppo somalo al-Shabaab. Infatti, alla luce della
recente internazionalizzazione operativa di al-Shabaab, è ravvisabile
l’intenzione di intensificare i rapporti tra le due formazioni per aprire un
nuovo fronte dell’insorgenza jihadista. L’Uganda è impegnata nella lotta ad
al-Shabaab nel contesto della missione AMISOM e potrebbe quindi rappresentare
un obiettivo sensibile per l’islamismo radicale del Corno d’Africa, come
confermato dai 2 attentati che hanno insanguinato Kampala nel 2010 e
dell’allarme terrorismo lanciato dalle autorità statunitensi lo scorso 3
luglio. Nella fattispecie, l’obbiettivo dei miliziani sarebbe stato l’aeroporto
internazionale di Entrebbe.
Fonte CESI Newsletters 152
Fonte CESI Newsletters 152
NIheria: Boko Haranall'attacco
Domenica 30 giugno, un gruppo di miliziani
presumibilmente parte di Boko Haram hanno attaccato i villaggi di Kwada, Ngurojina, Karagau e Kautikari, tutti
dislocati nei dintorni di Chibok, nello Stato nord-orientale del Borno,
provocando la morte di 54 persone. Anche in assenza di una rivendicazione, la
tipologia dell’attacco lascia presumere la responsabilità del movimento
jihadista. Di fronte all’ennesimo massacro di civili, le Forze Armate nigeriane
sono fuggite attirando su di esse le gravi accuse della popolazione locale,
abbandonata alla violenza dei miliziani. Inoltre, durante gli attacchi contro i
cristiani e i membri dell’Esercito, i miliziani sono stati appoggiati dalle
locali comunità musulmane, a testimonianza del crescente supporto popolare
verso il gruppo jihadista nelle remote aree settentrionali del Paese.
In questo senso, il malcontento sociale nei
confronti delle istituzioni civili e militari nigeriane potrebbe aver spinto
una parte della popolazione a collaborare con gli uomini d’affari e signori
della guerra locali, in contrasto con il governo nigeriano e in contatto con
Boko Haram. Molte di queste influenti personalità utilizzano l’insorgenza
salafita nel nord della Nigeria per destabilizzare il governo del Presidente
Goodluck Jonathan e massimizzare i propri benefici economici e politici, spesso
contigui alle attività criminali e terroristiche. La sempre maggiore fluidità
tra il mondo politico, le attività illegali e la militanza jihadista ha trovato
l’ennesima conferma nell’arresto, avvenuto lo scorso 1 luglio, del businessman
Babuji Ya’ari e di diverse donne accusate di spionaggio per conto del movimento
jihadista nonché di aver collaborato alla preparaz! ione di numerosi attacchi
verificatisi nel nord est della Nigeria.Fonte CESI. Newsletter 151
lunedì 22 settembre 2014
Libia: situazione fuori controllo
| Medio Oriente Alba contro Dignità, in Libia si muova l’Ue Roberto Aliboni 04/09/2014 |
|
 Le elezioni del 25 giugno scorso in Libia hanno portato a una netta rottura nel già dilaniato tessuto politico del paese. Questa frattura si è tradotta in uno scontro militare, non episodico, né localizzato, come quelli che si sono avuti sin qui.
Le elezioni del 25 giugno scorso in Libia hanno portato a una netta rottura nel già dilaniato tessuto politico del paese. Questa frattura si è tradotta in uno scontro militare, non episodico, né localizzato, come quelli che si sono avuti sin qui.Nell’ambito di questo scontro ci sono stati interventi di aerei militari stranieri, che hanno mostrato i nessi fra lo scontro in Libia e quello fra le diverse potenze sunnite della regione. In questo quadro, i paesi occidentali e l’Onu, impegnati a sostenere la pacificazione nazionale e la transizione del paese alla democrazia, sembrano finiti nell’angolo. Vorranno, potranno fornire una risposta adeguata?
Le elezioni del 25 giugno e la costituzione della nuova Camera dei Rappresentanti, al posto del Congresso nazionale generale, invece di rimettere sui binari la competizione politica fra le parti libiche si sono rivelate una sorta di estremo rantolo delle istituzioni democratiche della transizione e hanno contribuito a farla deragliare.
Elezioni che liquidano la democrazia
Nel febbraio del 2012, il Congresso, in preda a controversie inconciliabili e sotto il peso di una diffusa sfiducia popolare, aveva raggiunto un compromesso per rinnovarsi mediante nuove elezioni.
Nello stesso mese, tuttavia, il generale Khalifa Belkasim Hiftar annunciava la sua “Operazione Dignità” contro islamisti e “terroristi”, ricevendo un avallo da parte dei moderati dell’Alleanza delle forze nazionali.
Da questo punto in avanti, ogni possibilità che il dissidio fra islamisti e moderati si potesse risolvere nell’ambito delle istituzioni, come aveva fatto pensare il compromesso di febbraio, veniva meno. Islamisti e rivoluzionari radicali, mentre Hiftar avviava le sue operazioni in Cirenaica, hanno perciò cominciato a prepararsi allo scontro, comunque fosse andato avanti il processo istituzionale.
Le elezioni hanno poi mandato alla Camera dei Rappresentanti una maggioranza nettamente orientata verso i moderati. Tuttavia, la bassissima partecipazione al voto ha tolto loro ogni convincente legittimità.
Comunque, sono state interpretate da islamisti e rivoluzionari radicali come l’ultimo segnale della prevaricazione condotta dai moderati su di loro e di conseguenza sono iniziate le operazioni delle loro forze militari coalizzate sotto il nome di “Operazione Alba”.
La parola alle armi
Il 13 luglio le forze di “Alba” hanno attaccato l’aeroporto internazionale di Tripoli, tenuto sin dalla rivoluzione dalle brigate della città di Zintan, alleate dei moderati e perno della loro influenza nella capitale.
A Bengasi, il 29 luglio gli islamisti di Ansar al-Sharia hanno sloggiato le forze di “Dignità” dalla importante base di Buatni. Da allora, le forze islamiste cirenaiche continuano a premere su quelle di Hiftar che chiaramente annaspano.
L’aeroporto di Tripoli è caduto il 23 agosto. Attualmente, le forze della coalizione “Alba” spadroneggiano nella capitale, da dove i moderati si sono chiaramente ritirati. “Alba” ha occupato le sedi governative (e la ex residenza dell’ambasciatore americano).
Reagendo a tutto ciò, la Camera, riunita nella lontana Tobruk, ha riconfermato il governo di Al-Thinni, che s’era dimesso, ma la coalizione di “Alba” ha chiesto al vecchio Congresso di riunirsi e sta operando affinché sia nominato un “governo di emergenza” che avrebbe come premier Omar Hassi, un militante rivoluzionario della prima ora, che viene dai ranghi dei Fratelli Mussulmani.
La Camera ha caratterizzato i militanti di “Alba” come “terroristi fuori legge”. Il portavoce delle brigate di Misurata, punta di lancia di “Alba”, ha replicato che le operazioni a Tripoli avevano lo scopo di liberare le istituzioni “dai resti del vecchio regime” e che la Camera di Tobruk non fa altro che tentare di “screditare coloro che restano leali alla Rivoluzione del 17 Febbraio”, chiarendo così in epigrafe qual sia la percezione alla radice dello scontro tra i “veri rivoluzionari” e i “reazionari mascherati da rivoluzionari”.
Uno scontro di sponsor esterni
Nella battaglia di Tripoli sono intervenuti aerei degli Emirati Arabi Uniti, appoggiati logisticamente dall’Egitto. Militarmente non sono stati d’aiuto. Politicamente sono serviti a chiarire che il processo politico-istituzionale libico si collega al confronto fra le diverse potenze sunnite della regione e ne è inevitabilmente influenzato.
Non è un mistero che Qatar e Turchia appoggiano i Fratelli Mussulmani e le forze ad essi associate, mentre Arabia Saudita, Emirati ed Egitto sostengono un arco di moderati che va da Mahmoud Jibril a Khalifa Hiftar.
D’altra parte, non è chiaro se le forze jihadiste di Bengasi e Derna hanno sostenitori esterni o se, nell’ambito delle liaisons dangereuses disinvoltamente praticate da molti attori della regione, Qatar e Turchia appoggino anche loro. Certamente ricevono appoggio dalle diverse associazioni e "charities” del salafismo estremista del Golfo.
Con ancora maggiore certezza ricevono appoggi dai loro accoliti a partire dai vari fronti mediorientali e africani in cui la Jihad si trova oggi sul sentiero di guerra. Come che sia, nella fase attuale la contiguità fra estremisti e moderati islamisti s’è trasformata in alleanza.
Se contiguità e alleanze fra forze islamiste moderate ed estremiste costituiscono una difficoltà non nuova sulla strada di un’eventuale ripresa del processo politico-istituzionale, tale eventualità è certamente complicata dalle pesanti interferenze esterne in essere.
È questo certamente un problema in più per i paesi occidentali e l’Onu i quali, nel momento in cui un agitato mondo politico si sta trasformando in un’altra guerra civile, hanno subito denunciato le interferenze esterne e confermato l’obbiettivo di ricreare le condizioni perché il processo politico-istituzionale riprenda.
Responsabilità occidentali
Se l’obiettivo era difficile prima, lo è ancora di più ora. Non è chiaro come possa essere perseguito un dialogo nazionale e non ha più senso parlare di riforma del settore della sicurezza. In una guerra civile o si appoggia una parte o si cerca di creare le condizioni per un avvicinamento delle parti senza stare con nessuna di esse.
In Libia, l’aggregazione dei Fratelli Mussulmani con gli jihadisti e quella dell’Alleanza delle Forze nazionali con il generale Hiftar è il risultato di un processo politico in cui tutti i democratici libici hanno puntato all’esclusione dell’altro piuttosto che alla collaborazione (come è avvenuto in Tunisia).
In questo processo negativo le responsabilità dei governi rivali della regione è grande e appare crescente: essi hanno tutto l’interesse a tirare l’acqua al loro mulino piuttosto che a quello della Libia. C’è anche una responsabilità dell’Occidente?
Indubbiamente l’Occidente, finita la rivoluzione, si è volatilizzato, talvolta senza nemmeno preoccuparsi di capire perché mai fosse intervenuto. Ha lasciato l’Onu da solo. Ha esortato al dialogo, al processo politico e alla difesa delle istituzioni, ma mentre ha sviluppato contatti con i rivoluzionari moderati (persone di un mondo bene o male conosciuto) non risulta che abbia sviluppato contatti con i Fratelli Mussulmani nel tentativo di rassicurarli e impegnarli in un dialogo politico.
Questo fu fatto in Egitto dagli statunitensi (anche se, in conclusione, senza successo), ma in Libia non è stato neppure tentato. Forse ingaggiare i Fratelli libici, dissociarsi da Hiftar e altri elementi meno convincenti dell’area rivoluzionaria moderata, e convincere i Fratelli a distinguersi nettamente dagli jihadisti (come ha fatto a un certo punto Ennahda in Tunisia) potrebbe essere utile a far arretrare i libici dal baratro che si profila e aprire la strada a un dialogo di cooperazione e pacificazione nazionale. Dunque degli impegni politici e non una generica esortazione a fare i democratici.
Il primo passo dell’Occidente - rigetto delle interferenze esterne e riconferma della transizione democratica - può apparire ingenuo, ma è invece un gesto che trova un favore trasversale nell’opinione libica.
Per andare oltre ci vuole una diplomazia collettiva ben attrezzata e coordinata e, soprattutto una forte volontà politica. Non è escluso che i nuovi dirigenti dell’Ue riescano a mobilitare questa diplomazia collettiva e battere un colpo, per una volta, nella variegata tormenta che avvolge ormai da anni il loro vicinato meridionale.
Roberto Aliboni è consigliere scientifico dello IAI.
martedì 16 settembre 2014
LIbia: L'Italia deve essere prudente
| La crisi in Libia e l’Italia Primo, evitare di restare da soli Mario Arpino 09/08/2014 |
|
 Inviare in Libia una missione Onu a guida italiana, a similitudine di Unifil in Libano? Idea suggestiva quella espressa da Nicola Latorre, presidente della Commissione Difesa del Senato. E in prima analisi condivisibile, considerato che la stabilizzazione del Paese, dopo lo sconquasso cui anche noi abbiamo dato una mano robusta, è uno dei problemi più urgenti. Almeno per noi.
Inviare in Libia una missione Onu a guida italiana, a similitudine di Unifil in Libano? Idea suggestiva quella espressa da Nicola Latorre, presidente della Commissione Difesa del Senato. E in prima analisi condivisibile, considerato che la stabilizzazione del Paese, dopo lo sconquasso cui anche noi abbiamo dato una mano robusta, è uno dei problemi più urgenti. Almeno per noi.Il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, infatti condivide, riportando che anche gli Stati Uniti auspicano per l’Italia un ruolo di maggior peso nella regione. “A patto che - aggiunge - vi siano un coordinamento a livello internazionale ed un ruolo non subalterno”.
Fare qualcosa, ma non qualsiasi cosa
Apprezzata questa immediatezza propositiva, è utile qualche riflessione. È vero, l’Italia, con storiche responsabilità verso quell’aggregato di tribù e territori che al momento chiamiamo ancora Libia, deve muoversi per prima e “fare qualcosa”.
Tanto più che i nostri interessi sono rilevanti e con potenziale sviluppo. È anche evidente che dobbiamo adoperarci perché la Libia mantenga una configurazione statuale unitaria, anche se in ciò erano riusciti per qualche decina d’anni solo i Romani e, dopo di loro, il governatore Italo Balbo. Oltre, naturalmente, a Muhammar Gheddafi.
Perché uno sforzo tipo Unifil possa essere coronato dal successo, è necessario il verificarsi di un certo numero di evenienze, che potremmo provare ad elencare e discutere. Sono d’ordine politico, ma anche pratico e militare, visto che tra Libia e Libano in comune ci sono solo le tre lettere iniziali.
La prima è una perplessità: avrà l’Italia la forza e gli strumenti per trainare il Consiglio di Sicurezza verso la pace, così come Sarkozy era riuscito a trascinarlo in tempi brevi verso la “guerra”? Mi si perdoni l’inverecondia del termine, ma è difficile dare un nome diverso ad alcuni mesi di bombardamenti.
Capire bene quali e quanti sono gli amici, e i nemici
Dalla Libia è arrivata in questi giorni una richiesta di aiuto internazionale. È davvero valida, o è solo la voce isolata di un gruppo scarsamente rappresentativo? È vero, ci sono state le elezioni del 25 giugno, e il nuovo Parlamento ha già provato a riunirsi. Ci è stato detto che l’affluenza alle urne è stata del 42 per cento, ma si è sorvolato sul fatto che il dato si riferisce agli iscritti alle liste, non al totale degli aventi diritto.
Così, i circa 630 mila votanti su 3,4 milioni di elettori rappresentano una percentuale inferiore al 20 per cento. Quindi, l’80 per cento circa dei libici non si è espresso. Come la pensano costoro? Le milizie hanno sempre dichiarato di non voler cedere le armi, opponendosi a qualsiasi intervento di forze straniere: è cambiato qualcosa? Non sembra. Chi raccoglierà l’appello, supponendo - cosa niente affatto scontata - un’approvazione del Consiglio?
Accortisi dello sconquasso di cui erano i primi responsabili, Francia, Regno Unito e prima ancora gli Stati Uniti, dopo le bombe si sono immediatamente defilati. Idem Nato e Unione europea (Ue), mentre Cina e Russia è probabile siano ben soddisfatte di aver favorito, con l’astensione, quel tranello che ha così ben contribuito a screditare l’Occidente.
Cosa è rimasto? Un’Italia con il cerino tra le dita, un Mare Nostrum pieno di disperati, un dirimpettaio ridotto al fallimento, i nostri interessi calpestati e messi a repentaglio.
Ora, è legittimo chiedersi: perché i tre grandi, dopo averci coinvolto in una guerra che era con tutta evidenza contro i nostri interessi, dovrebbero adesso scendere in campo per tutelarli? Diciamolo fuori dai denti, la stabilità di una Libia unitaria interessa solo noi. La Nato, con gli Usa lontani, militarmente conterebbe come la Ue: assai poco. Nemmeno il flusso dei migranti preoccupa l’Europa, se il commissario per gli affari interni, Cecilia Malmström, ci ha appena spiegato che ci sta portando enormi benefici.
Meglio procedere per gradi
L’idea del senatore Latorre resta affascinante, ma al momento forse è prematura. Ben che vada, ci troveremmo alla guida di qualche migliaio di soldati dell’Unione Africana, sempre disponibile quando si tratta di finanziare i propri eserciti con le casse dell’Onu.
La Libia è grande, le tribù numerose, i gheddafiani ancora attivi nel Sud. C’è da dubitare che con queste forze sia possibile disarmare le milizie, o anche solo interporsi. Al-Sisi, a est, potrebbe aiutare, ma non va dimenticato che i nostri interessi e quelli egiziani in Cirenaica potrebbero anche divergere.
Prima di pensare ad una missione militare dell’Onu, cui, in questo momento, sarebbe oltremodo difficile assegnare un mandato, serve ancora molto lavoro di preparazione. Ed è proprio qui che l’Italia potrebbe distinguersi, prendendo l’iniziativa. Per esempio, tentando di organizzare a Roma una conferenza semipermanente di tutte le parti in causa, che includa le diverse componenti libiche, l’Egitto, la Tunisia e l’Algeria, da sempre interessata ad una stabilizzazione del Sud.
Giornalista pubblicista, Mario Arpino collabora con diversi quotidiani e riviste su temi relativi a politica militare, relazioni internazionali e Medioriente. È membro del Comitato direttivo dello IAI.
LIbia: la situazione ad agosto 2014
| Medio Oriente Libia verso la somalizzazione Roberto Aliboni 31/07/2014 |
|
 L’evacuazione dalla Libia di cittadini stranieri, uomini d’affari, diplomatici e tecnici ha assunto un ritmo serrato.
L’evacuazione dalla Libia di cittadini stranieri, uomini d’affari, diplomatici e tecnici ha assunto un ritmo serrato.Il motivo occasionale sta nelle due sanguinose battaglie in corso: all’aeroporto di Tripoli lo scontro è fra le milizie di Zintan - nazional liberali - e quelle di Misurata - filo islamiste; a Bengasi, Ansar al-Sharia e altri estremisti islamici combattono contro una coalizione di milizie più o meno politicamente apparentabili con quelle di Zintan, fra cui quella formata negli ultimi mesi dall’ex generale Khalifa Haftar.
Lo scontro di oggi ha però un profilo politico diverso dal conflitto a bassa intensità di tutti contro tutti che abbiamo conosciuto nei due anni precedenti e certamente prefigura una svolta.
Da una parte, la multipolarità della crisi libica - il moltiplicarsi di conflitti fra i più disparati attori - appare in declino. Dall’altra, le violenze in corso sembrano mettere definitivamente in causa il processo politico di transizione democratica che si era messo in moto dopo la rivoluzione. Entrambe questi fattori possono determinare un salto di qualità nei conflitti in atto.
Nei due anni passati, la crisi libica è stata un rompicapo a causa del suo carattere multipolare, di tutti contro tutti: le tribù, le etnie, la Cirenaica e la Tripolitania. Più di recente alcuni di questi conflitti, pur lungi dall’essere risolti, hanno però cominciato a recedere. Ciò vale per l’occupazione dei terminali petroliferi, la tensione fra i “federalisti” cirenaici e il centro tripolino e il conflitto fra gli Awad arabi e i Tubu nell’estremo sud del paese.
Conseguenze della legge per l’epurazione
Si è invece rafforzato il conflitto di fondo che nei due anni passati è fermentato fra le forze rivoluzionarie esclusive e quelle inclusive. Lo scontro è avvenuto, in particolare, sulla legge per l’epurazione, che ha sancito severi criteri di esclusione per tutti quei leader e funzionari che avevano servito sotto il regime di Muammar Gheddafi.
Questi criteri si sono rivelati così rigidi da escludere anche Mahmoud Jibril, uno dei leader indiscussi della rivoluzione (anche se a era in precedenza nei ranghi dell’amministrazione del regime).
Beninteso, la legislazione sull’epurazione non è nata come strumento di esclusione dei nazional-liberali ma, cammin facendo, la coalizione islamista nel Congresso generale (i Fratelli Mussulmani e il Blocco dei Martiri di Abu Sahmain) l’ha indubbiamente usata proprio a questo scopo: per rovesciare i governi e la maggioranza dominati dall’Alleanza delle Forze Popolari dei nazional-liberali.
Milizie e lotta per il potere
Diplomatici e analisti internazionali hanno continuato a interpretare il processo politico libico come una transizione fondamentalmente consensuale verso la democrazia, in cui erano impegnati sia nazional-liberali che islamisti liberali, anche se disturbata, ahimé, dalla prevaricazione delle milizie, forti del monopolio della forza a fronte di un governo privo di mezzi coercitivi.
In realtà, c’è stata una dura lotta per il potere, in cui tutte le parti in conflitto non hanno esitato a usare a loro vantaggio le milizie, al fine di escludere l’avversario. Gli islamisti, in particolare, non hanno neppure esitato, quando gli è convenuto, di allearsi con i jihadisti di Derna e Bengasi.
I Fratelli Mussulmani e i loro alleati non hanno accettato la loro condizione di minoranza nel Congresso e nel paese, fino al tentativo di nominare, malgrado minoranza, un loro governo al posto di quello di Ali Zeidan, dopo averlo costretto alle dimissioni e alla fuga dal paese.
Fallito questo tentativo, il 25 giugno si sono fatte elezioni legislative con l’obiettivo di rinnovare lo screditato Congresso Generale, cui è stata data anche la nuova denominazione di Camera dei Rappresentanti.
Anche le elezioni sono state però un fallimento. Alle elezioni si sono candidati solo indipendenti, essendo stati esclusi i partiti. Nessuno perciò è in grado di dire quale tendenza la nuova Camera esprimerà e in che tempi. Non è neanche chiaro se la Camera dei Rappresentanti riuscirà a riunirsi, ma è evidente che, se pure ci riuscisse, non sarà certo in grado di avviare quel processo politico che in due anni ha registrato solo fallimenti. Il nuovo Parlamento è anzi assurto a simbolo della fallita transizione democratica.
Ruolo comunità internazionale
La comunità internazionale non può illudersi di stabilizzare il paese, riattivando un processo politico finito in un vicolo cieco o cercando di addestrare le forze di sicurezza necessarie a ridare al governo libico (quale governo?) il monopolio della forza.
Così il futuro della Libia sembra sempre più dipendere dall’esito del conflitto, come in alcuni paesi del Levante. Nessuno vuole intervenirvi militarmente, né è in grado di esercitare una qualche influenza politica significativa. Per la Libia si profila quindi uno scenario simile a quello della Siria: difficoltà a individuare dei partner a parte intera; quindi, assai scarsa convinzione e impegno nel sostenerli; in conclusione, un’influenza insignificante.
In Libia però la destabilizzazione ha effetti più immediati sull’Europa e sui suoi interessi. Inoltre, non esiste, come in Siria, un centro politico strutturato come quello degli Assad. In questo senso, la Libia sembra avviata più verso il destino della Somalia che della Siria, cioè a diventare un vero e proprio stato fallito.
Difficilmente però l’Europa può restare a guardare. Dagli Stati Uniti gli europei possono aspettarsi un appoggio, ma non un’iniziativa che surroghi, come al solito, la loro. Dagli arabi possono aspettarsi di più, in particolare dall’Egitto e, forse dall’Arabia Saudita, ma su un terreno politico molto scivoloso.
Il rischio è che l’Europa sia coinvolta in uno dei tanti conflitti settari che stanno sconvolgendo la regione e finisca per essere trascinata in un confronto contro jihadisti e/o Fratelli Mussulmani, politicamente inopportuno per i suoi interessi. È venuto il momento che a questi sviluppi e ai gravi rischi che essi comportano si ponga finalmente mente, e che lo si faccia al più presto.
Roberto Aliboni è consigliere scientifico dello IAI.
mercoledì 10 settembre 2014
NIgeria: proseguono gli attacchi di Boko Haram
Domenica 30 giugno, un gruppo di miliziani
presumibilmente parte di Boko Haram hanno attaccato i villaggi di Kwada, Ngurojina, Karagau e Kautikari, tutti
dislocati nei dintorni di Chibok, nello Stato nord-orientale del Borno,
provocando la morte di 54 persone. Anche in assenza di una rivendicazione, la
tipologia dell’attacco lascia presumere la responsabilità del movimento
jihadista. Di fronte all’ennesimo massacro di civili, le Forze Armate nigeriane
sono fuggite attirando su di esse le gravi accuse della popolazione locale,
abbandonata alla violenza dei miliziani. Inoltre, durante gli attacchi contro i
cristiani e i membri dell’Esercito, i miliziani sono stati appoggiati dalle
locali comunità musulmane, a testimonianza del crescente supporto popolare
verso il gruppo jihadista nelle remote aree settentrionali del Paese.
In questo senso, il malcontento sociale nei
confronti delle istituzioni civili e militari nigeriane potrebbe aver spinto
una parte della popolazione a collaborare con gli uomini d’affari e signori
della guerra locali, in contrasto con il governo nigeriano e in contatto con
Boko Haram. Molte di queste influenti personalità utilizzano l’insorgenza
salafita nel nord della Nigeria per destabilizzare il governo del Presidente
Goodluck Jonathan e massimizzare i propri benefici economici e politici, spesso
contigui alle attività criminali e terroristiche. La sempre maggiore fluidità
tra il mondo politico, le attività illegali e la militanza jihadista ha trovato
l’ennesima conferma nell’arresto, avvenuto lo scorso 1 luglio, del businessman
Babuji Ya’ari e di diverse donne accusate di spionaggio per conto del movimento
jihadista nonché di aver collaborato alla preparaz! ione di numerosi attacchi
verificatisi nel nord est della Nigeria.Fonte CESI Newsletter 151
martedì 9 settembre 2014
Kenya: attacco terroristico con 49 uccisi
|
lunedì 8 settembre 2014
Egitto: scarso peso sulla scena internazionale
| Conflitto israelo-palestinese Egitto, mediatore fantasma Andrea Dessì, Azzurra Meringolo 13/07/2014 |
|
 In questi giorni di guerra, gli egiziani hanno aperto solo per poche ore il valico di Rafah, l’unico ingresso della Striscia di Gaza non gestito ad Israele.
In questi giorni di guerra, gli egiziani hanno aperto solo per poche ore il valico di Rafah, l’unico ingresso della Striscia di Gaza non gestito ad Israele.Dal valico passano non solo i feriti più gravi che cercano soccorso in Egitto, ma anche le speranze della tregua dell’ennesima escalation di violenza tra israeliani e palestinesi, la più violenta dal novembre 2012.
Tramonto della luna di miele
A mediare una tregua nel 2012 fu proprio il Cairo. Da allora molto è cambiato nella regione. L’asso nella manica della mediazione egiziana fu il rapporto tra i Fratelli Musulmani - rappresentati al Cairo dal presidente Mohammed Morsi - e i cugini di Hamas, costola della confraternita islamista che ha il potere su Gaza. Da quando la Fratellanza è rinchiusa nelle carceri egiziane, la luna di miele tra gli arabi al di qua e al di là di Rafah è finita.
Il nuovo presidente egiziano Abdel Fattah Al-Sisi spera che la disfatta dei cugini palestinesi indebolisca i Fratelli egiziani, nemici dell’esercito dal quale proviene. Per questo dal Cairo avevano fatto capire che questa volta l’Egitto non avrebbe provato a mediare. Ora, però, questa posizione sembra ammorbidirsi e l’Egitto ricompare sulla scena come un possibile mediatore.
Un portavoce del presidente egiziano dice infatti che Sisi ha promesso al presidente dell’Autorità Palestinese - che amministra la Cisgiordania - di alzare la cornetta per chiamare quanti possono fare qualcosa per far cessare la mattanza. Più tardi Abu Zuhri, un portavoce di Hamas, ha rivelato all’agenzia Bloomberg l’esistenza di contatti tra Gaza e il Cairo.
Rivelazioni interessanti non solo perché qualsiasi mediazione di successo deve coinvolgere Hamas - e non solo l’Autorità palestinese che ha a sua volta problemi con gli islamisti che governano Gaza - ma anche perché fanno pensare che gli sforzi di mediazione egiziani di cui si parlava a metà giugno non si sono esauriti.
Sisi possibile negoziatore
Non è quindi escluso che Sisi decida di far scendere in campo i suoi negoziatori. Gli islamisti palestinesi non sono il suo alleato naturale, ma il presidente egiziano non vuole rinunciare a influire sull’ordine regionale, come gli chiede anche la Casa Bianca.
Nonostante le voglie neoisolazioniste degli americani e il morale a pezzi del segretario di Stato John Kerry dopo il fallimento dell’ennesimo tentativo di riappacificare Israele e Palestina, Washington desidera ancora un Medio Oriente stabile. L’Egitto rimane quindi una pedina importante.
Le parti in conflitto non sono però ancora pronte a deporre le armi.
Per la diplomazia Usa il primo obiettivo è quello di scongiurare un’invasione di terra da parte del governo israeliano. Tel Aviv, dal canto suo, vuole punire la leadership di Hamas, accusata, pur senza prove convincenti, dell’uccisione dei tre giovani israeliani, e impedire la riconciliazione tra gli islamisti di Hamas e i nazionalisti di Fatah.
La spina nel fianco dell’accordo tra Fatah e Hamas
Alla base di questo conflitto c’è infatti anche il recente annuncio dell’accordo di riconciliazione tra Fatah e Hamas e l’insediamento del nuovo governo di consenso nazionale a Ramallah con l’appoggio delle due fazioni palestinesi.
A sovraintendere alla nascita di questo esecutivo è stato Moussa Abu Marzouq, stratega di Hamas, famoso per la capacità di tessere con successo la tela dei rapporti e delle mediazioni tra Egitto-Gaza e i servizi segreti israeliani. Abu Marzouq - caso vuole - è l’unico uomo di Hamas a risiedere in Egitto anche dopo la stretta repressiva dei militari nei confronti degli islamisti.
Sebbene il governo sia di natura tecnica e quindi senza ministri affiliati a Hamas, Israele ha da subito condannato il nuovo esecutivo, dichiarando che non dialogherà con un governo di ‘terroristi’. Di diverso avviso sono però le principali potenze internazionali, Stati Uniti, Unione europea, Cina, India e Russia.
Difficile pensare che, dopo l’ennesima escalation di violenza tra Hamas e Israele e la perdurante collaborazione tra Fatah e Israele sulla sicurezza in Cisgiordania, il recente accordo di riconciliazione nazionale Hamas-Fatah possa sopravvivere.
La divisione politico-militare tra la Striscia di Gaza, controllata da Hamas, e la Cisgiordania di Fatah continuerà a minare gli obiettivi nazionali della Palestina. Non a caso, il premier israeliano Benjamin Netanhayu addita questa divisione come prova della mancanza di un partner riconosciuto dall’intera popolazione palestinese con il quale siglare un accordo di pace.
Mentre si aspetta che un mediatore con serie intenzioni - egiziano, turco, saudita o statunitense che sia - si faccia avanti, gli scontri si inaspriscono, così come le tensioni intra-palestinesi.
Andrea Dessì è assistente alla ricerca dello IAI.
Azzurra Meringolo è ricercatrice presso lo IAI e caporedattrice di Affarinternazionali. Coordinatrice scientifica di Arab Media Report. Potete seguirla sul suo blog e su twitter a @ragazzitahrir.
giovedì 4 settembre 2014
Egitto: le elezioni del 7 giugno

Martedì 7 giugno sono stati ufficializzati i risultati delle elezioni tenutesi tra il 26 e il 28 maggio scorsi. Nella road-map di transizione delineata dal governo ad interim salito al potere il 3 luglio 2013 l’elezione del presidente rappresenta la seconda tappa; la successiva ed ultima consisterà nelle elezioni parlamentari, probabilmente a fine estate. Al-Sisi, dichiarato vincitore, ha tenuto il suo primo discorso da presidente per ringraziare gli egiziani e il suo rivale, la cui presenza ha reso l’elezione “competitiva”. Le virgolette sono necessarie dal momento che Sabahi ha ottenuto l’impossibile: è riuscito ad arrivare terzo in una corsa a due, come ha titolato l’articolo di Bel Trew pubblicato dal Middle East Institute. Il candidato di sinistra ha ottenuto circa 757 mila voti contro gli oltre 23 milioni di Al-Sisi e contro un milione di schede nulle. Queste ultime sono state superiori rispetto a tutte le elezioni tenutesi in Egitto dopo la rivoluzione del 2011, comprese le pur notevoli 834.252 (3%) schede nulle espresse su sollecitazione di una vera e propria campagna di boicotaggio nelle elezioni del 2012, quando si fronteggiavano l’ex Primo Ministro di Mubarak, Ahmed Shafik e Mohamed Morsi. Le immagini delle schede invalidate, che hanno preso a circolare su tutti i social media, spaziano da quelle che invocano la liberazione degli attivisti politici imprigionati a quelle che esprimono un’ironica preferenza per le più varie celebrità. Escludendo quelle plausibilmente frutto di errori involontari, nonostante le autorità avessero allentato le regole elettorali, permettendo agli elettori di disegnare sulla scheda senza invalidarla purchè venisse almeno barrata una casella, ciò che risulta è un sentimento diffuso di pubblica irriverenza nascosto fino al momento dello spoglio da un crescendo nazionalista che ha pervaso i giorni della campagna elettorale.
I partiti che hanno deciso di sostenere la candidatura di Sabahi hanno subito una batosta non da poco, dimostrando la loro lontananza dagli umori della gente. Molti, d’altro canto, avevano messo in discussione la sua candidatura, che conferiva implicita legittimità a delle elezioni considerate una farsa sia dagli islamisti che dai dissidenti laici. Ci si chiedeva come un candidato autodefinitosi rivoluzionario potesse scegliere di partecipare alle elezioni da cui il più grande gruppo politico egiziano era stato bandito e che si verificavano dopo 10 mesi di violenta repressione contro ogni forma di dissenso. Sabahi, dal canto suo, riteneva che candidarsi fosse l’unico modo per garantire lo svolgimento di un processo democratico in Egitto o almeno per porne le basi. Ahmed el-Enany, membro dell’ufficio politico di Sabahi, ha affermato: “Possiamo vincere o perdere, ma non possiamo ritirarci dalle elezioni. Ritirarsi è pericoloso per noi, per il paese e per il popolo perchè darebbe alla Fratellanza la possibilità di avvalorare la loro posizione”.
Il piano di Sabahi ora è cercare di rimettersi in corsa per le prossime elezioni parlamentari, ma il danno alla sua immagine, dovuto alla partecipazione alle presidenziali, potrebbe produrre effetti anche nella prossima tornata elettorale. Alcuni, infatti, lo considerano ora un ingranaggio della solita macchina corrotta che ha portato all’Egitto l’ennesimo militare come presidente.
In una dichiarazione il NASL (l’Alleanza Nazionale di sostegno alla legittimità), che è quanto rimane della Fratellanza, ha richiesto ai militari di fare un passo indietro e permettere, così, agli egiziani di governare. Il basso livello di affluenza, inoltre, ha evidenziato secondo l’Alleanza che gli egiziani rigettano quello che è definito dagli islamisti un colpo di stato militare. Il NASL, perciò, chiede agli egiziani di protestare in tutti i governatorati contro i risultati delle elezioni e contro la destituzione del legittimo presidente Morsi.
Neanche il vincitore può considerarsi pienamente soddisfatto dal voto, dal quale puntava di ottenere, infatti, una legittimazione indiscussa e indiscutibile, basata su un’affluenza totale di almeno 40 milioni di votanti. Nei primi due giorni il governo ad interim era così preoccupato dalla bassa affluenza, che, per facilitare il voto, ha proclamato il secondo giorno di elezioni festa nazionale; ha giurato di non multare i cittadini trovati senza biglietto sui mezzi pubblici e alla fine ha esteso le elezioni per un terzo giorno. Tutto ciò per evitare che la credibilità del processo elettorale venisse minata e con essa l’inevitabile vittoria di Al-Sisi.
Nonostante ciò, solo 25 milioni di elettori si sono recati alle urne, ovvero il 47% circa, su un totale di 54 milioni di elettori registrati. I dati dell’affluenza forniti dalla Commissione delle Elezioni Presidenziali (PEC), già inferiori rispetto al 52% delle elezioni del 2012 vinte da Morsi, non possono, però, essere confrontati e verificati con altri. Nelle elezioni precedenti i controlli venivano effettuati principalmente incrociando i dati ufficiali con quelli di altri gruppi politici, come la Fratellanza Musulmana o attraverso il monitoraggio effettuato dai rappresentanti dei concorrenti. Ora la Fratellanza è fuori dai giochi e i rappresentanti della campagna di Sabahi hanno subito attacchi ed arresti da parte delle forze di sicurezza, finchè il candidato nasserista non ha deciso di ritirarli dai seggi la notte del 27 maggio. Come risultato, il dato dell’affluenza finale non può essere verificato e confermato dalle missioni elettorali presenti in loco e sono piovute accuse da più parti sulla sua credibilità e imparzialità. Il Presidente di Democracy International (DI), una delle sei missioni di osservatori elettorali stranieri accettata dal Cairo, ha dichiarato: “Non abbiamo i mezzi per valutare l’affluenza alle urne”. Nel frattempo, sospetti di brogli hanno iniziato a circolare dopo la denuncia di un funzionario presente in uno dei seggi, secondo il quale i voti scrutinati sarebbero stati superiori a quelli dei votanti registrati. Nel complesso “il contesto repressivo egiziano ha reso elezioni genuinamente democratiche impossibili”, ha dichiarato Eric Bjornlund, Presidente di Democracy International. La legge sulle proteste ha avuto effetti parimenti negativi sulla libertà di associazione e di espressione. Infine, l’estensione all’ultimo minuto della votazione per 24 ore è stata ritenuta ingiustificata, poiché nei due giorni precedenti non si erano verificati ostacoli al suo corretto svolgimento.
Dello stesso parere la missione elettorale dell’Unione Europea, che ha pubblicato il suo rapporto provvisorio, nel quale si afferma che l’estensione delle elezioni per un terzo giorno non è stata contraria alla legge, ma ha portato “incertezza inutile” nel procedimento. Sia Sabahi che Al-Sisi hanno inviato un reclamo formale contro la decisione, entrambi respinti dalla Commissione elettorale, così come il ricorso avanzato da Sabahi al PEC sulla dubbia credibilità dei risultati finali e sulla presenza di irregolarità durante le votazioni. Il rapporto UE ha giudicato il processo elettorale in sé regolare, ma il contesto nel quale esso è avvenuto viene descritto come ampiamente anti-democratico. Per queste ragioni, il movimento dei giovani del 6 aprile, banditi qualche mese dopo i Fratelli Musulmani, aveva invitato l’UE a non inviare gli osservatori per non legittimare delle elezioni ritenute una farsa. A sostegno di questa posizione sta l’effettiva limitazione della libertà di espressione e l’esclusione di diversi attori dal processo politico da parte delle autorità. Le condanne a morte di centinaia di presunti affiliati alla Fratellanza Musulmana – mentre Mubarak se la cavava con 3 anni di carcere per appropriazione indebita – gli arresti di attivisti politici, l’uso eccessivo della violenza da parte delle forze di sicurezza e l’arresto di numerosi giornalisti hanno creato un clima diffuso di paura. Inoltre, non si può sostenere che i candidati abbiano giocato su un piano paritario. Infati, i finanziamenti alle campagne non sono stati regolamentati e i media hanno dedicato il doppio del tempo ad Al-Sisi rispetto a quello riservato al suo rivale Sabahi. Poco prima e durante le elezioni ha preso piede una vera e propria isteria mediatica in cui i presentatori equiparavano l’astensione dal voto al tradimento e stigmatizzavano chiunque differisse per opinione dalla narrazione propagandata dalle autorità governative. Questo ha impedito lo sviluppo di un qualsiasi dibattito.
“Finora Al-Sisi ha solo fatto l’anti-Morsi. Adesso il nuovo regime dovrà iniziare a lavorare”, ha affermato Simon Williams, economista capo di HSBC Middle East. Gli elementi di forza su cui potrà contare il neo-presidente sono, in primo luogo, il sostegno delle forze armate e degli interessi costituiti e, in secondo luogo, l’enorme popolarità dovuta alla credenza diffusa che l’ex Generale sia l’unico, al momento, in grado di riportare la stabilità dopo anni di sconvolgimenti. Tuttavia, l’affluenza al voto più bassa di quanto Al-Sisi sperasse, potrebbe non garantire un mandato popolare abbastanza ampio per le decisioni difficili che il governo dovrà prendere su tre piani: sicurezza, stabilità e sviluppo economico. Non c’è dubbio che stabilità e sicurezza siano condizioni necessarie allo sviluppo, ma esse non saranno sufficienti.
Il messaggio di Al-Sisi è stato chiaro fin dall’inizio: l’esercito, il governo e il popolo sono una cosa sola e la lotta contro ogni opposizione è una lotta comune, che risponde alle esigenze della nazione. Sembra che il neo-presidente abbia preso alla lettera il pensiero di Charles de Gaulle, che sosteneva: “Per diventare il padrone, il politico deve atteggiarsi da servo”. Per questo Al-Sisi non perde occasione per mostrarsi vicino al suo popolo e ai problemi che affliggono la maggioranza degli egiziani, soprattutto nel caso degli effetti negativi dell’estremismo islamico. Nella famosa intervista tv pre-elettorale, per esempio, Al-Sisi aveva denunciato i due attentati alla sua vita subiti da parte dei terroristi islamici. Stando alle dichiarazioni pre-elettorali, il nuovo regime spenderà presumibilmente molte energie nella lotta contro gli islamisti, che non si lasceranno reprimere con facilità, abituati ad agire in condizioni di clandestinità. Già troppe volte, infatti, l’islamismo politico è stato dato per morto, ritrovando poi in contesti diversi modo per riattualizzarsi.
Più morbida, invece, è sembrata la posizione di Amr Moussa, ex Ministro degli Esteri e attuale Consigliere della campagna presidenziale di Al-Sisi, che in una dichiarazione alla stampa ha affermato: “La porta è aperta per chiunque voglia partecipare al processo politico. Se la Fratellanza Musulmana desidera farlo, deve riconoscere pubblicamente la costituzione, abbandonare la violenza e riconoscere la legittimità delle nuove istituzioni”. La nuova costituzione, secondo Moussa, non isolerebbe nessuno, diversamente da quella islamista del 2012. In risposta, Ahmed Abdul-Aziz, Consigliere di Morsi, ha spento le speranze di chi credeva in una riconciliazione, impossibile con chi ha portato a compimento un colpo di stato militare e non una rivoluzione come sostenuto dalla leadership attuale. La riconciliazione potrà avvenire solo quando sarà fatta giustizia per tutti i sostenitori di Morsi o presunti tali uccisi dalle forze di sicurezza a partire dall’estate del 2013, come ha affermato da Londra Mohammed Sudan, Segretario del partito Libertà e Giustizia. Inoltre, la decisione spetterebbe in quel caso solo al legittimo presidente Morsi ed è con lui, quindi, che il governo dovrà dialogare se è realmente interessato alla riconciliazione.
Più morbida, invece, è sembrata la posizione di Amr Moussa, ex Ministro degli Esteri e attuale Consigliere della campagna presidenziale di Al-Sisi, che in una dichiarazione alla stampa ha affermato: “La porta è aperta per chiunque voglia partecipare al processo politico. Se la Fratellanza Musulmana desidera farlo, deve riconoscere pubblicamente la costituzione, abbandonare la violenza e riconoscere la legittimità delle nuove istituzioni”. La nuova costituzione, secondo Moussa, non isolerebbe nessuno, diversamente da quella islamista del 2012. In risposta, Ahmed Abdul-Aziz, Consigliere di Morsi, ha spento le speranze di chi credeva in una riconciliazione, impossibile con chi ha portato a compimento un colpo di stato militare e non una rivoluzione come sostenuto dalla leadership attuale. La riconciliazione potrà avvenire solo quando sarà fatta giustizia per tutti i sostenitori di Morsi o presunti tali uccisi dalle forze di sicurezza a partire dall’estate del 2013, come ha affermato da Londra Mohammed Sudan, Segretario del partito Libertà e Giustizia. Inoltre, la decisione spetterebbe in quel caso solo al legittimo presidente Morsi ed è con lui, quindi, che il governo dovrà dialogare se è realmente interessato alla riconciliazione.
Per quanto riguarda il piano economico, invece, Al-Sisi e il suo entourage riconoscono la necessità di procedere con il varo di misure di austerità e hanno già avvisato gli egiziani che dovranno stringere la cinghia per almeno due anni, per permettere di portare il deficit all’8,5% del PIL e il debito pubblico al 74,5% entro il 2017-2018.
L’economia egiziana è peggiorata significativamente negli ultimi 3 anni, con la crescita ferma al 2% annuo, l’inflazione in doppia cifra, la disoccupazione a più del 13%, il deficit al 14% del PIL e il debito pubblico a più del 90% del PIL. Ancora peggio le riserve di valuta estera, che sono scese a soli 18 miliardi di dollari dai 35 miliardi del 2010. Non sono state annunciate ancora misure specifiche per raggiungere tali ambiziosi traguardi, ma quel che è certo è che non si potrà prescindere dalla riforma dei sussidi, finora rimandata. Uno dei test più difficili riguarderà, in particolare, i sussidi energetici, che ingoiano miliardi di dollari statali ogni anno. I sussidi sono sempre stati alla base del contratto sociale tra governanti e governati e nel budget del 2011-2012 rappresentavano il 72% del totale. Finora sono stati intrapresi solo aggiustamenti limitati, ma nessun governo ha mai lanciato un programma serio di riforma, nonostante il sistema avesse fallito anche nel suo obiettivo ultimo e cioè favorire le classi più povere promuovendo la giustizia sociale. L’80% della popolazione, infatti, beneficia solo del 20% dei sussidi, mentre il 20% beneficia del restante 80. Gli imprenditori hanno sollecitato Al-Sisi ad alzare i prezzi del settore energetico, anche se questo potrebbe portare alle proteste popolari. Un leggero aumento del prezzo del gas naturale si è già verificato, ma non sarà sufficiente a migliorare la situazione.
È probabile che presto l’Egitto si affiderà anche ai prestiti del Fondo Monetario Internazionale, finora evitati per due ragioni principali. In primo luogo, grazie all’aiuto ingente dei paesi alleati del Golfo non vi era una necessità impellente di nuovi prestiti. Inoltre, dopo la rivoluzione del 2011, nessun governo è stato nelle condizioni di lanciare le massicce riforme economiche che un prestito del FMI avrebbe comportato. Il governo di transizione guidato dal Consiglio Supremo delle Forze Armate dopo la cacciata di Mubarak rimandò queste decisioni ad un governo eletto. Il governo di Morsi, invece, non riuscì a vincere l’opposizione a molte delle riforme ecomiche da varare, tra cui l’aumento delle tasse. Infine, il governo ad interim insediatosi dopo la destituzione di Morsi il 3 luglio 2013 rimandò la decisione ai vincitori delle successive elezioni. Ora potrebbero esserci le condizioni necessarie. Nel frattempo, le iniezioni di capitali dal Golfo serviranno a tamponare le falle del sistema egiziano.
In campo internazionale l’intesa dell’Egitto con il fronte guidato da Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti sta prendendo una forma sempre più strutturata. Gli Emirati hanno salutato l’elezione dell’ex Generale come un segno di “nuova speranza” per l’Egitto, mentre il re saudita Abdullah ha commentato l’elezione di Al-Sisi come “una vittoria storica”. Il monarca ha, poi, annunciato la convocazione di una conferenza di paesi donatori per aiutare l’Egitto a risollevarsi economicamente. Insieme agli Emirati, l’Arabia Saudita aveva già promesso all’Egitto un pacchetto di aiuti di 20 miliardi di dollari, come annunciato da un funzionario del governo al giornale Al-Masry Al-Youm. Il pacchetto comprenderà depositi nella Banca centrale per sostenere la sterlina egiziana, in drastico calo rispetto al dollaro; prestiti a basso tasso di interesse; investimenti in progetti idrici, sanitari e scolastici oltre che un’abbondante fornitura di prodotti petroliferi. Non a caso, il primo viaggio all’estero di Sisi avrà come destinazione proprio Riyad, in segno di gratitudine verso la dinastia saudita.
I governi occidentali, dal canto loro, ammettono che la road map di Sisi non potrà includere le stesse aspirazioni democratiche che hanno accompagnato la caduta di Mubarak, ma la realpolitik e i solidi interessi comuni che legano il Cairo all’Occidente avranno la meglio. La posta in gioco, infatti, è troppo alta: combattere i militanti jihadisti nel Sinai, mantenere la pace con Israele e rilanciare l’economia sono solo alcune delle priorità occidentali.
Gli israeliani sono forse i più sollevati dal fatto che i militari siano tornati al potere in Egitto: fin da quando Sadat ha aperto le porte agli investimenti stranieri, infatti, l’esercito è stato un buon cliente con il quale fare affari in brutti momenti, e, come Morsi, anche Al-Sisi accetta che il trattato di pace sia sacrosanto. Il Regno Unito rimane il principale fornitore di investimenti diretti esteri in Egitto e gli ingenti debiti nei confronti delle aziende britanniche non verranno pagati facilmente se Londra non mantiene buoni rapporti con il Cairo. L’industria della difesa americana, dal canto suo, ha sempre fatto affidamento sul partner egiziano e sulla sua sete di armamenti. Per quanto riguarda, invece, l’Unione Africana, che aveva espulso l’Egitto dall’organizzazione dopo la cacciata di Morsi, essa si trova ora sotto la crescente pressione dell’Unione Europea affinchè riveda la propria decisione e riassegni la membership al nuovo Egitto di Al-Sisi.
Lo scenario più probabile per l’avvio di questa presidenza vede la continuazione della respressione contro le fazioni estremiste e il tentativo di riconciliazione con le forze dell’opposizione più moderate, tenute comunque ai margini dell’arena politica, oltre che la cooptazione di un’ampia serie di attori che avevano giocato un ruolo centrale durante la presidenza Mubarak.
Qualora la repressione contro l’opposizione islamista e laica non risciusse a porre fine alla violenza interna, fomentata anche dalla crisi libica e dall’instabilità cronica della regione mediorientale, diventerebbe quasi impossibile risollevare l’economia, che subirebbe gli effetti negativi sia dell’instabilità interna che della sfiducia dei mercati internazionali. Di conseguenza, verrebbero danneggiate anche le relazioni con Europa e Stati Uniti e si riproporrebbe lo stesso scenario caotico dei tre anni appena trascorsi. Dal caos i Fratelli Musulmani e i movimenti giovanili di Piazza Tahrir potrebbero prendere nuova forza e riconquistarsi lo spazio loro sottratto presentandosi come l’unica reale alternativa al potere dei militari.
mercoledì 3 settembre 2014
Buona ripresa
Anno Accademico 2014-2015
Dopo la pausa estiva, riprendono le pubblicazioni dei post. Saranno messi anche quelli relativi a Luglio ed Agosto per completamento di archivio e non avere buchi per le ricerche, ma non saranno rinviati
A Tutti,
frequentatori, studenti e lettori un augurio di una felice ripresa e di un proficuo lavoro
(email geografia2013@libero.it)
Iscriviti a:
Post (Atom)